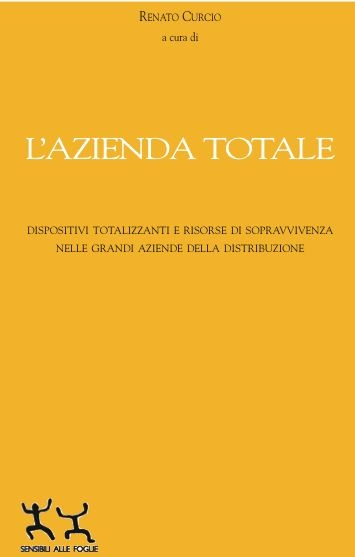La crisi della «democrazia organizzata». A proposito di "La democrazia è una causa persa? Paradossi di un’invenzione imperfetta", un libro di Alfio Mastropaolo (Recensione di Damiano Palano) Democrazia in default La lettera inviata dal Governatore della Banca Centrale Europea al governo italiano nello scorso mese di agosto è diventata rapidamente una sorta di simbolo della condizione delle nostre democrazie, che ci appaiono, sempre di più, come democrazie tenute in scacco dai mercati internazionali e sorvegliate (se non addirittura ‘commissariate’) dalle istituzioni sovranazionali. Così, sembra che ai governi spetti solamente l’esecuzione di decisioni prese altrove e che la volontà dei cittadini diventi solo un fastidioso inconveniente con cui, ogni quattro o cinque anni, ci si deve confrontare. Da questo punto di vista, è quasi paradigmatico che il contenuto specifico della lettera inviata dal Governatore Trichet al Presidente del Consiglio italiano sia stato per lunghi mesi tenuto segreto all’opinione pubblica. Le politiche che quella lettera suggeriva erano piuttosto prevedibili, almeno nei loro contorni generali (dal momento che non faceva che riformulare le indicazioni che le istituzioni finanziarie internazionali prescrivono periodicamente agli esecutivi più o meno di tutti i paesi occidentali). Ma il fatto che il testo della lettera sia rimasto a lungo celato – prestandosi così a mille utilizzi, e destando molte sospettose recriminazioni – è in fondo il simbolo più efficace dalla ‘trasparenza’ così spesso evocata dall’Ue, e così clamorosamente violata. E ancor più significativo è che un organo ‘tecnico’ dell’Unione Europea – un organo ‘neutrale’ rispetto ai singoli governi nazionali, e che dunque dovrebbe mantenersi estraneo alle dinamiche politiche – abbia dettato (o suggerito) misure considerate vitali. Al di là delle semplificazioni, l’idea di una democrazia ‘svuotata’ dei propri poteri – e di uno Stato privato della propria «autonomia» (più o meno relativa) – coglie effettivamente almeno alcuni tratti delle trasformazioni che nell’ultimo trentennio hanno attraversato i sistemi politici occidentali, proprio perché si connette con le modificazioni dell’economia globale, con la transizione geo-politica in atto e con il mutamento nel ruolo dello Stato: un mutamento per nulla scritto nelle ‘leggi’ del determinismo economico, ma in gran parte conseguenza di decisioni politiche, particolarmente evidenti nel Vecchio continente e nei paesi coinvolti nel processo di integrazione europea. E, così, non è affatto sorprendente che negli ultimi anni, per effetto di queste trasformazioni radicali – e per molti versi irreversibili – si sia consolidata nel dibattito l’idea di una modificazione strutturale delle democrazie occidentali che, sovente, sembra preludere ad una vera e propria ‘crisi’. In un testo recente, Carlo Galli – accantonando la formula ‘crisi’ – ha definito «disagio della democrazia» la condizione in cui si trova oggi l’Occidente rispetto all’ideale della democrazia e alle istituzioni democratiche. Si tratta, secondo Galli, di un disagio duplice: da un lato, «si manifesta con una disaffezione, con un’indifferenza quotidiana per la democrazia che equivale a una sua accettazione passiva e acritica, al rifiuto implicito dei suoi presupposti più complessi e impegnativi» (C. Galli, Il disagio della democrazia, Einaudi, Torino, 2011, pp. 3-4); dall’altro, è anche un disagio strutturale, un disagio che «nasce dall’inadeguatezza della democrazia, dei suoi istituti, a mantenere le proprie promesse, a essere all’altezza del proprio obiettivo umanistico, a dare a ciascuno uguale libertà, uguali diritti, uguale dignità» (ibi, p. 4). A questo disagio – soggettivo e oggettivo – vengono date però risposte diverse, sia perché la lettura delle trasformazioni in atto è differente, sia perché la stessa concezione della democrazia – dei suoi obiettivi, dei suoi fondamenti, dei suoi caratteri distintivi – risulta tutt’altro che riconducibile a un modello unanimemente condiviso. Tra gli osservatori più ‘pessiministi’, Colin Crouch, per esempio, sostiene che ci troviamo ormai in una sorta di ‘post-democrazia’, o che comunque la democrazia occidentale abbia imboccato la fase discendente della propria parabola storica (C. Crouch, Postdemocrazia, Laterza, Roma – Bari, 2003). Massimo L. Salvadori definisce invece i regimi democratici contemporanei come sostanzialmente oligarchici e dominati da «plutocrazie» compatte (M.L. Salvadori, Democrazie senza democrazia, Laterza, Roma – Bari, 2009), in cui soprattutto la dimensione dell’eguaglianza sociale, grande obiettivo delle democrazie postbelliche, diventa sempre meno rilevante (come osserva per esempio N. Tranfaglia, La democrazia è ancora un’utopia?, in «l’Unità», 31 agosto 2011, pp. 40-41). Una visione sostanzialmente simile emerge anche dal quadro delineato, per esempio, da Sheldon Wolin a proposito del sistema politico americano (S. Wolin, Democrazia Spa, Fazi, Roma, 2011), oppure dalla lettura proposta da Wendy Brown, secondo cui nei paesi occidentali è in atto un processo di de-democratizzazione che comporta, fra l’altro, la fusione del potere economico con il potere statale. Altri osservatori, adottando una chiave di lettura meno pessimista, certo riconoscono la realtà di alcune trasformazioni, ma non ritengono né che la fisionomia distintiva della democrazia – ossia l’esistenza di alcune fondamentali procedure – venga colpita in modo rilevante, né che il venir meno di alcuni diritti (in particolar modo dei diritti sociali) configuri qualcosa di più che il semplice riflesso di un mutamento ideologico (cfr. in questo senso il recente fascicolo di «Paradoxa» Quelli che… la democrazia, a proposito del quale rimando alle osservazioni critiche svolte in Il rischio della critica della critica). Ma, anche in quest’ottica, difficilmente possono essere sottovalutate o negate le dimensioni delle sfide che oggi sono poste ai sistemi democratici. Perché – come ha scritto per esempio Ernesto Galli della Loggia, un osservatore tutt’altro che incline a inalberare la bandiera di una democrazia ‘tradita’ dalle promesse del liberismo economico – ciò che oggi appare messo in discussione, prima ancora delle singole politiche pubbliche, o delle linee programmatiche portate avanti dalle diverse coalizioni di governo, è la stessa capacità degli Stati democratici di ‘governare’ i molteplici flussi che attraversano i confini nazionali, o che influiscono sulle risorse a disposizione. La globalizzazione – o, prima di tutto, la sua radice tecnologica, che riduce gli spazi contraendo il tempo – innesca processi che sfuggono totalmente, o nella massima parte, alla presa del controllo statale. Per utilizzare le parole di Galli della Loggia, la difficoltà che oggi sperimentano le democrazie occidentali «è legata alla ridotta estensione dello spazio statale, al suo restringimento di fatto, dovuto principalmente alla velocità ormai fantastica di ogni genere di comunicazione, vicino ormai al traguardo dell’istantaneità» (E. Galli della Loggia, La democrazia non è in rete, in «Corriere della Sera», 13 settembre 2010, p. 1 e 34). Proprio per questo, la democrazia si trova – se non del tutto impotente – comunque in larga parte disarmata dinanzi a queste sfide:
«stretto come in una tenaglia dentro una spazialità da un lato dominata dall’immediatezza e dall’altro caratterizzata dalla lontananza, il regime democratico vede oltre modo indebolite le sue antiche possibilità di controllo e di autonomia). Per entrambi i versi vede assottigliarsi i margini della sua sovranità: e tanto più in quanto proprio le sue caratteristiche democratiche, la sua tutela dei diritti individuali e collettivi, rendono sempre più problematica la difesa di quella sovranità. La quale, lungi dall’essere ‘superata’ a favore di inesistenti e fantasmatiche sovranità sovra o internazionali – come credono gli ottimisti – viene semplicemente messa in mora da altre minisovranità al suo interno ovvero, dalle leggi senza volto della tecnologia, che operano nell’interesse esclusivo di sé medesime e/o degli incontrollabili interessi economici (per esempio della finanza o della grande informazione commerciale globale)» (ibidem). Per comprensibili motivi, in Italia il dibattito teorico sulle trasformazioni della democrazia si è però intersecato con le discussioni sulle sorti della democrazia italiana, sulle ‘promesse non mantenute’ della Seconda Repubblica e del bipolarismo, oltre che sui molteplici conflitti di interesse che rendono quasi inestricabile la trama del potere. Così, la riflessione sul ‘presente’ e sul ‘futuro’ della democrazia è stata spesso declinata in una direzione specifica, che forse ha finito col rendere la matassa ulteriormente intricata, proprio perché ha condotto nel vicolo cieco dell’«anomalia italiana». Nel suo ultimo libro, La democrazia è una causa persa? Paradossi di un’invenzione imperfetta (Bollati Boringhieri, pp. 363, euro 18.00), Alfio Mastropaolo cerca invece di sbrogliare la matassa di questo dibattito, esaminando, uno per uno, i molti fili che si aggrovigliano nell’idea della ‘crisi’ della democrazia, e, soprattutto, inquadrando le trasformazioni dei nostri sistemi politici in un’ottica di lungo periodo, in grado per questo di sfuggire alle scorciatoie teoriche o retoriche e a una prospettiva eccessivamente ‘italo-centrica’.
Un’invenzione umana
Inserendosi in un dibattito ormai piuttosto affollato, il libro di Mastropaolo ha alcuni grandi meriti. Il primo consiste nel rimettere la democrazia ‘con i piedi per terra’, ossia nel ‘demitizzare’ il concetto di democrazia, distinguendo la storia dell’ideale – che percorre la vicenda occidentale con alterne fortune e che si intreccia con le aspirazioni all’eguaglianza politica, giuridica e sociale – dalla concreta realtà delle istituzioni politiche rappresentative. Per molti versi, Mastropaolo, sotto questo profilo, si limita a segnalare un punto che la retorica celebrativa della «fine della Storia» ha finito con l’offuscare, e da cui è stato contagiato – in modo purtroppo non episodico – anche il campo di quanti, per mestiere, studiano le trasformazioni dei sistemi politici. Mentre rifiuta l’immagine che rappresenta la democrazia liberale contemporanea come il punto di arrivo dell’evoluzione politica e ideologica del genere umano, Mastropaolo non offre però soltanto un antidoto al profluvio retorico dell’ultimo ventennio, perché consente anche di considerare la democrazia contemporanea come un ‘prodotto’ storico, risultato di scontri, di conflitti, di soluzioni non sempre preordinate, oltre che come un’«invenzione imperfetta». Ed è infatti proprio l’adozione di questa prospettiva analitica che spinge Mastropaolo a collocare la storia intellettuale e politica della democrazia contemporanea in un quadro articolato, capace di tenere insieme dimensioni diverse.
Prima ancora di formulare previsioni sul futuro della democrazia, Mastropaolo invita infatti alla cautela a proposito del modo di utilizzare la stessa parola ‘democrazia’ e della tentazione di attribuire al regime democratico promesse che non può mantenere. Benché sia una formula straordinariamente evocativa, la ‘democrazia’ – ricorda Matropaolo proprio nelle prime pagine – è un’«invenzione umana e un fatto storico»:
«Anche se ne ha la pretesa, non è il sommo bene. Non è il destino della specie, né una necessità. Ha avuto un’origine da qualche parte, donde si è largamente diffusa, modificandosi e adattandosi, ed è destinata ad avere una fine. Come per tutti i fatti storici, un largo margine di casualità ne segna nascita, fortuna e traversie» (ibi, p. 7).
Nel corso del tempo, soprattutto dopo la fine del blocco sovietico, la democrazia ha mostrato tutta la sua «smisurata ambizione», diventando «una parola magica, che beneficia di un pregiudizio positivo resistente a qualsiasi riserva e che consacra tutto quanto riveste, che annuncia addirittura l’impegno a trasformare i governati in governanti e quindi ad abrogare il potere» (ibidem). Ma la democrazia non può davvero mantenere l’altisonante promessa di consegnare il potere al popolo e di trasformare i governati in governanti (e anche per questo – come suggerisce Robert Dahl – sarebbe forse più appropriato definire i sistemi politici occidentali come ‘poliarchie’). Al di là della retorica, ciò che chiamiamo ‘democrazia’ è infatti – come scrive Mastropaolo – solo una «tecnologia del potere»:
«Spogliata dei suoi sacri paramenti, la democrazia è null’altro che una tecnologia del potere trattante, utile a coordinare, prescrivere, condizionare, orientare la condotta d’individui e gruppi sociali, quindi a regolare la vita collettiva e a dirimere i conflitti che la agitano. Storicamente si è rivelata in special modo appropriata alle società differenziate e pluralistiche proprie della modernità, ma il nesso non è obbligato: tali società le si è governate anche reprimendo il pluralismo e imponendo il conformismo» (ibi, p. 26).
Mastropaolo non si limita però a spogliare la democrazia dei suoi abiti più solenni, perché mostra anche come qualcosa nell’ultimo trentennio – a dispetto di un’apparente continuità – sia effettivamente cambiato. In primo luogo, secondo il politologo, è infatti cambiato il nostro modo di concepire la democrazia. Se nel secondo dopoguerra, la democrazia viene incardinata nei partiti e nelle organizzazioni sociali, che hanno sia la funzione di aggregare e mediare gli interessi, sia quella di integrare i gruppi nello Stato, a partire dagli anni Ottanta la democrazia tende invece a essere concepita – non solo nel dibattito teorico – come la forma di regime in cui i cittadini designano i loro governanti in elezioni competitive, in modo analogo a quanto fanno i consumatori scegliendo il prodotto preferito tra quelli che offre il mercato. Un simile passaggio – che ovviamene riflette una modificazione nelle relazioni sociali e nei rapporti di forza – viene in parte testimoniato a livello teorico dal contrasto fra i sostenitori di una ‘democrazia sostanziale’ e gli alfieri di una concezione puramente ‘procedurale’ della democrazia: un contrasto che ha radici profonde e che si protrae fino a oggi. Scrive Mastropaolo a questo proposito: «Per quanti sforzi di conciliazione si compiano, in sede politica come in sede teorica la controversia tra democrazia formale e sostanziale resta al momento insolubile. Meglio: il proceduralismo prevale. Alla contesa sul significato sono palesemente sottesi un conflitto di valori e una lotta di potere, che sono la stessa cosa. I regimi democratici sorti nel secondo dopoguerra coniugavano, nei loro stessi dettati costituzionali, le due dimensioni, ma l’accordo era provvisorio ed è stato disdetto. I due significati della parola democrazia si sono allontanati, addirittura entrando in collisione. Che non convegna contentarsi della convergenza attorno alla democrazia procedurale, che dovrebbe almeno rendere pacifico il confronto?» (ibi, p. 37).
Anche se, sotto un profilo strettamente teorico, la contrapposizione fra visioni ‘sostanzialiste’ e visioni ‘proceduraliste’ non è risolvibile, Mastropaolo osserva però che la questione, dal punto di vista storico, presenta un paradosso che non può essere sottovalutato: Il paradosso è che, una volta ridotta la democrazia a procedura, non è affatto scontato che alle sue politiche non sia prescritto alcun contenuto. Anche quando la si vorrebbe addirittura scheletrica, scarnificata da ogni impedimento alla sovranità popolare, ridotta a poche regole e a qualche minimo presupposto, essa è ben in carne. Se la democrazia – procedurale – è un modo per regolare la competizione politica, un contenuto è prescritto alle politiche democratiche anche quando ci si s’impunta a vietarne ogni altro. In teoria la democrazia procedurale consente il welfare e può non consentirlo. Ma, se siamo realisti, la storia non passa invano. Dopo una lunga stagione di attenzione a un certo tipo di misure politiche, rivendicare un proceduralismo sbrigativo e disseccato implica ufficializzare l’indifferenza della democrazia alle diseguaglianze. Definire democraticamente illegittimo, dopo decenni di Stato sociale, che chi governa si astenga di fronte alla povertà, alla malattia, all’ignoranza, e affidare ogni intervento riparatorio ai governanti in carica, implica riconoscere piena legittimità alle diseguaglianze, non senza vantaggio per i ceti abbienti» (ibi, p. 39).
In altre parole, l’idea che la democrazia debba essere definita soltanto da una serie di procedure non risolve i problemi una volta per tutte, perché non si possono sottovalutare i mutamenti che, nel corso del Novecento, sono avvenuti proprio in ordine alle procedure, e che hanno prodotto non poche conseguenze sulle dinamiche delle democrazie occidentali. Proprio esaminando queste trasformazioni ‘nelle’ procedure, Mastropaolo colloca il mutamento delle democrazie occidentali in un quadro più ampio, che coinvolge i processi economici e gli assetti sociali.
Democrazia e post-fordismo
Nel corso della sua analisi, Mastropaolo individua cinque grandi modificazioni ‘nelle’ procedure. Le prime – l’universalizzazione del suffragio e l’intensificazione dei diritti – avvengono nelle prime stagioni della democratizzazione. Le altre – il ridimensionamento del potenziale di mobilitazione dei grandi numeri, la limitazione del campo di applicazione delle procedure democratiche più restrittive (per esempio, mediante l’istituzionalizzazione delle procedure di governance, o l’introduzione di autorità indipendenti), l’adozione procedure di governo d’emergenza – risalgono invece agli ultimi tre decenni, e accompagnano una trasformazione che innesca la riduzione nella garanzia dei diritti. A questa modificazione nel concetto di democrazia si accompagnano – e si affiancano – anche mutamenti profondi nella società e nei sistemi politici. Ed è proprio a questo livello che è possibile riconoscere il secondo merito dell’operazione di Mastropaolo. La gran parte del dibattito politologico tende infatti a considerare la democrazia – le sue trasformazioni storiche, le tappe della democratizzazione, il rendimento istituzionale, o persino la ‘qualità’ di un regime democratico – come il prodotto di circostanze che stanno ‘al di fuori’ del sistema politico, e che possono riflettersi – più o meno direttamente – sulla dinamica e sull’efficienza delle istituzioni. Per esempio, la ‘cultura politica’ o il ‘capitale sociale’ possono favorire la stabilità o l’efficienza del sistema, una determinata configurazione dell’economia può determinare un assetto economico-sociale che va a incidere positivamente o negativamente sulla vitalità della ‘società civile’ e, dunque, sulle stesse istituzioni democratiche, o, infine, la presenza di fratture nel tessuto culturale di un Paese può rendere più difficile la formazione di esecutivi omogenei e stabili. In ognuna di queste ipotesi – che ovviamente continuano a fornire contributi validi – la connessione fra ‘società’ e ‘politica’ appare – come nella metafora sistemica – come il rapporto che si viene a creare fra l’ambiente e una ‘scatola nera’ in cui si prendono le decisioni politiche: si tende perciò a pensare alla politica, al sistema politico e ai suoi attori, in termini funzionali rispetto all’ambiente sociale e alle sue mutevoli richieste. Col risultato che la ‘politica’ è pensata come un insieme di apparati che sono chiamati a ‘rispondere’, con politiche più o meno appropriate, alle richieste provenienti dalla società, e che invariabilmente appaiono in ‘ritardo’ rispetto ai mutamenti.
Molto probabilmente, è invece più utile adottare uno schema che, pur senza invertire l’ordine dei fattori (e dunque senza evocare l’idea di una politica capace di plasmare la società a propria immagine e somiglianza), consideri i mutamenti del sistema economico-sociale e del sistema politico in parallelo, come dimensioni differenti ma connesse delle relazioni di potere che si producono nella società. Mastropaolo compie proprio un’operazione di questo genere, perché la sua analisi delle trasformazioni che avvengono ‘nelle’ procedure democratiche è inserita nel quadro di un grande processo, che il politologo descrive nei termini di un passaggio cruciale dal «capitalismo organizzato» a un «capitalismo disorganizzato», e cioè all’assetto post-fordista.
Per quanto le modalità con cui il dibattito ha dato conto di questo insieme di processi siano molto differenti, gli elementi di fondo su cui Mastropaolo di concentra sono tre: a) il processo di globalizzazione economica; b) la decadenza dell’azione regolatrice dello Stato; c) la rottura del precedente assetto di relazioni industriali e la modificazione del profilo del lavoro dipendente (ibi, pp. 89-92). Pertanto, la traiettoria seguita a partire dagli Ottanta appare segnata da una logica interna piuttosto coerente: «Inaugurato da una straordinaria rivoluzione tecnologica, quella dell’informatica, il trentennio postfordista è segnato da una manovra politica fondamentale. Da un lato lo Stato ha rinunciato a difendere l’occupazione, pubblica e privata, e i servizi pubblici, a benefico della crescita economica e dei profitti delle imprese. Da lato opposto, col pieno consenso delle autorità politiche nazionali e sovranazionali, i frutti della crescita, i profitti imprenditoriali, ma anche i risparmi delle famiglie e gli accantonamenti pensionistici, sono stati dirottati nel gorgo della speculazione finanziaria globale. Non tutti i risparmi, ma in misura variabile, e con un grado di consapevolezza diversa da parte degli attori, senza tuttavia sortire significative riduzioni della spesa pubblica, perché altre esigenze erano insorte nel frattempo, né sempre si è ridotta la pressione fiscale, mentre è in genere cresciuto il costo dei servizi. Di contro, tra attività finanziarie e attività produttive si è aperto un drammatico contrasto, a tutto vantaggio delle prime. A ulteriore discapito degli investimenti, dell’occupazione, nonché del benessere dei cittadini e della stessa coesione sociale» (ibi, pp. 93-94). In parallelo al passaggio dal «fordismo» al «post-fordismo», la transizione alla stagione del «post-materialismo» scava in profondità sotto il terreno dei grandi soggetti della politica. In qualche misura, sembra prodursi un doppio movimento, perché l’azione ‘dall’alto’ – nei processi economici e politici – trova un corrispettivo al livello delle relazioni interpersonali. Così, mentre lo Stato e i partiti perdono (anche per propria decisione) potere di intervento nella sfera economica e sociale, la stessa politica – con i suoi grandi ideali e i suoi miti novecenteschi – viene di fatto logorata da una costante azione di ‘delegittimazione’, proveniente dal ‘basso’, dalla società. A segnare la tappa di un passaggio d’epoca è – secondo Mastropaolo – il celebre La crisi della democrazia, il rapporto alla Commissione Trilaterale steso da Crozier, Huntington e Watanuki, alla metà degli anni Settanta, perché proprio in quel rapporto il politologo intravede tanto i segnali di una lettura destinata a imprimersi nell’immaginario dei decenni seguenti, quanto l’anticipazione di una serie di linee di intervento politico che, di lì a poco, tutti i governi occidentali avrebbero adottato in modo più o meno coerente (ibi, pp. 140-141). Il rapporto scandiva, secondo Mastropaolo, «il transito dal paradigma democratico di matrice kelseniana a quello postdemocratico, di cui Schumpeter è fondamentale – benché un po’ tradito – ispiratore» (ibi, p. 142). Nel rapporto si possono così trovare le tracce originarie di quella trasformazione che investe le democrazie occidentali: secondo Mastropaolo, si registra una passaggio da un modello ‘kelseniano’ di democrazia – in cui sono fondamentali le procedure, ma in cui esse prevedono per esempio la costante ricerca del compromesso fra le diverse parti della società, un ruolo cruciale da parte dei partiti politici, la rappresentanza politica proporzionale – a un modello ‘schumpeteriano’, all’interno del quale la partecipazione popolare si risolve sempre più nella semplice indicazione del leader, oltre che nella decisione delle sorti della competizione elettorale. Un simile passaggio ha ovviamente i suoi effetti (oltre che alcune sollecitazioni) anche nel dibattito politologico, all’interno del quale la proposta schumpeteriana viene ulteriormente superata ed estremizzata, in una combinazione fatale con gli assunti di un liberalismo economico spesso non immune da deformazioni biecamente ideologiche. E le ricadute sul terreno dell’indagine della scienza politica finiscono con l’incoraggiare spesso l’abbandono di qualsiasi spirito critico e col produrre un’autentica rivoluzione lessicale, su cui Mastropaolo si sofferma, non senza una condivisibile ironia: «Tutto un dizionario di parole e concetti è caduto in desuetudine: le classi, lo Stato, la solidarietà, l’eguaglianza, il collettivo, il pubblico, l’interesse generale, il bene comune, il collettivo, l’interesse generale, il bene comune, il partito, il lavoro, il compromesso. Al loro posto sono balzati in primo piano l’individuo, il mercato, l’impresa, la governabilità, il profitto, il merito, la leadership, cui da ultimo, quando si sono cominciate ad apprezzare le inefficienze, malgrado tutto, del mercato, e le manchevolezze del nuovo ordine democratico, si sono aggiunti, oltre all’ormai onnipresente società civile, l’identità, il capitale sociale, i legami deboli, i networks, la trasparenza, l’accountability, la sussidiarietà, la governance, il nonprofit, il terzo settore e via di seguito. Non li abbiamo citati neanche tutti, ma c’è di che riempirne un dizionario» (ibi, p. 151). Se la «democrazia organizzata» postbellica si reggeva su partiti e organizzazioni degli interessi (associazioni imprenditoriali e sindacati), e se proprio per questo riusciva a ‘organizzare’ la vita collettiva, a partire dagli anni Ottanta proprio questi pilastri si sgretolano gradualmente. Si sgretolano per effetto dei mutamenti economici, ma anche in seguito a quella modificazione ‘culturale’, che allontana i cittadini dai partiti e che favorisce invece la moltiplicazione di mobilitazioni al di fuori dei canali istituzionali della rappresentanza. In realtà, nessuna delle grandi promesse del neo-liberalismo è stata davvero mantenuta, e Mastropaolo segnala per esempio come il livello della spesa pubblica – a dispetto di tanta retorica – non sia diminuito negli ultimi decenni, ma abbia semmai fatto segnare un riorientamento. Inoltre, non è neppure corretto descrivere questo insieme di processi nei termini di una «spoliticizzazione», perché – come scrive - «è politico anche il diverso dosaggio di dispositivi regolativi, così come sono politici i processi di alienazione del settore pubblico dell’economia, nonché le nuove gerarchie del potere stabilitesi nelle società democratiche a seguito dei processi privatizzazione e deregulation e della cessione di cospicue competenze alle autorità sovranazionali» (ibi, p. 167). Infine – e questo è un passaggio estremamente importante – l’apparente ‘declino dello Stato’ ha coperto, in realtà, la crescita della discrezionalità di autorità tecniche, burocratiche e anche politiche (ibi, pp. 167-171), tanto che si è trattato di un processo, al tempo stesso, di ‘spoliticizzazione’ e ‘politicizzazione’, come nel caso emblematico del New Public Management:
La politicità della burocrazia weberiana è stata negata, ma in compenso è cresciuta la sottomissione formale dei suoi vertici al potere esecutivo. È quest’ultimo che detta gli obiettivi di gestione, che sceglie il management – secondo criteri fiduciari e non senza qualche sospetto di spoil system – e ne verifica i risultati, proiettando su di esso i suoi orientamenti politici. Allontanate le amministrazioni dai partiti, si è soprattutto ristretto il luogo a cui provengono le pressioni della politica, potenziando tali pressioni con l’abbattimento di antiche barriere – il monopolio delle procedure e il rispetto delle norme – che proteggevano, seppur imperfettamente, le ex burocrazie weberiane, oggi riconvertite all’efficienza e alla discrezionalità del management (ibi, p. 171). In questo modo, allora, il passaggio verso la ‘post-democrazia’ schumpeteriana non configura affatto quel ‘dimagrimento’ dello ‘Stato panciuto’ di cui hanno parlato molti osservatori – deviati da uno schema liberale, che contrappone meccanicamente ‘Stato’ e ‘mercato’ – bensì una modificazione nella logica di erogazione della spesa pubblica e dell’intervento statale. Una modificazione che non ha certo ‘eliminato’ la politica, ma che ha piuttosto spostato il potere decisionale in un ambito ‘tecnico’: Ridisegnando la stateness, si sono volute sottrarre a quest’ultima ampie porzioni di potere, per trasferirle a un’altra politica, fatta dalle authorities, dalle banche centrali, dagli esperti, dagli attori del mercato. Con ciò, un’accanita – e cruciale – partita si è giocata proprio tra gli addetti alla politica, la quale ha tra loro istituito nuove gerarchie e una nuova organizzazione del lavoro (ibi p. 183).
Le trasformazioni nella stateness sono ovviamente strettamente correlate al mutamento che avviene nel «secondo fondamentale pilastro» della democrazia organizzata, e cioè i partiti, oltre che nella composizione e nel ruolo della classe politica. A questo proposito, sintetizzando i risultati di una sterminata letteratura, Mastropaolo ricostruisce le traiettorie di un processo che inizia a modificare il profilo del partito già a partire dagli anni Sessanta, da quando Otto Kirchheimer prese a intravedere i contorni del catch-all-party. Ma si tratta naturalmente di una dinamica che subisce un’accelerazione a seguito dell’impatto della logica mediatica, che d’altronde – e Mastropaolo lo sottolinea – i partiti stessi incoraggiano, senza essere così del tutto passivi e disarmati dinanzi all’incedere della mediatizzazione (cfr. ibi, pp. 201-203). E, soprattutto, si tratta di un processo che si interseca con quella ‘presidenzializzazione’ strisciante che investe i sistemi politici occidentali e che altera la classica distinzione fra legislativo ed esecutivo. A dispetto della reiterata critica mossa ai partiti – e alla «partitocrazia» – di essere soltanto latori di interessi specifici, settoriali, ‘di parte’, la ridefinizione del loro ruolo e della loro fisionomia ha condotto al paradosso di un ritorno in scena, da protagonisti, degli interessi frazionali. «Tra le accuse più frequenti rivolte ai partiti» - scrive Mastropaolo - «c’è quella di veicolare interessi parziali. Anche a prenderla sul serio, e a credere nell’esistenza di un interesse generale, difficile è però negare che se non vi fossero stati partiti in grado di rappresentare gli interessi diffusi e di mobilitare i grandi numeri, alcuni interessi parziali – quelli degli ambienti economici – avrebbero ottenuto un ascolto predominante. Che è quello che da ultimo sta accadendo» (ibi, p. 217). Naturalmente, Mastropaolo si riferisce non soltanto agli interessi economici, ma in generale agli ‘interessi concentrati’. Il punto è però che la pressione di tali gruppi sulle istituzioni di governo non può che crescere proprio contestualmente all’erosione del ruolo di linkage fra cittadini e istituzioni in precedenza assolto dai partiti e dal sistema partitico nel suo complesso. Il politologo non esclude che la mobilitazione torni in futuro a essere ‘incapsulata’ all’interno delle organizzazioni partitiche, ma deve prendere atto che oggi non ci sono segnali rilevanti che paiano preludere a una simile eventualità. Anche perché – sottolinea Mastropaolo – i partiti stessi sembrano rimanere soggiogati dal potere suggestivo della «democrazia dello scontento», ossia di quel «racconto di successo» (ibi, p. 220) che rappresenta i cittadini come insoddisfatti, delusi, disincantati rispetto alla democrazia e alla politica. Segnali in questa direzione provengono dal calo della partecipazione alle consultazioni elettorali (benché non manchino controtendenze e nonostante molti studiosi non ritengano simili dati rilevanti per valutare lo stato di salute di una democrazia), dalle differenze fra astensione sistematica e abituale, dall’aumento della volatilità elettorale, o dalle rilevazioni sul clima di opinione, che più o meno in tutti i paesi occidentali fanno registrare da anni un’altissima sfiducia nei confronti della politica. Tutti questi segnali – avverte però Mastropaolo – sono a loro volta la conseguenza di quello stesso mutamento che è andato a colpire i pilastri della «democrazia organizzata». Non si tratta, cioè, esclusivamente di un cambiamento culturale, bensì anche di un cambiamento che gli stessi partiti hanno più o meno implicitamente alimentato: abbandonando la funzione di canalizzatori del dissenso sociale verso determinati obiettivi politici e verso il personale politico (e quantomeno verso una sua parte), gli stessi partiti hanno infatti contribuito a radicare i sentimenti di insoddisfazione e discredito. «A osservare gli attori politicamente rilevanti che gareggiano nel classificare come malessere atteggiamenti e gesti ben più articolati», scrive per esempio Mastropaolo, «appare legittimo il sospetto che la politica stessa si presti a recitare la parte del capro espiatorio di quanto nella società non funziona e d’ogni sorta di malcontento» (ibi, p. 250). In sostanza, il personale politico non solo non ha tentato di rigettare l’accusa rivolta contro la politica, ma ha addirittura trasformato l’antipolitica in una preziosa risorsa retorica. «Per questo, oltre ad abusare imprudentemente dei media e dei sondaggi, senza posa ripetono imprudentemente il racconto del malessere, sebbene ne patiscano l’azione corrosiva», e, «inoltre, verso la politica mostrano essi stessi un atteggiamento non solo critico, ma irriverente, quando non sprezzante» (ibi, p. 251). Rispetto al quadro postbellico, anche la democrazia contemporanea si basa su un armistizio, benché le clausole siano ben differenti rispetto a quelle del passato. «Se tuttavia nel corso del primo ciclo il mondo del lavoro era ritenuto politicamente troppo forte per rischiare la collisione, nel secondo altrettante energie sono state spese per disperderlo, per naturalizzare le diseguaglianze e per riformulare l’idea stessa di conflitto» (ibi, p. 314). Così, benché sotto il profilo formale non siano intervenute rotture, nella realtà la dinamica appare come nettamente diversa: «L’armistizio postbellico presupponeva il conflitto di classe e provava a mediarlo. Nell’attuale situazione il conflitto parrebbe scomparso, insieme alle classi sociali. Non ritenendolo più una risorsa politicamente spendibile – anche nelle forme più disciplinate che aveva assunto – l’azione collettiva è stata screditata e riclassificata come spreco e motivo di disturbo. Ma parcellizzare e occultare il conflitto non basta a cancellarlo. Ne mutano semmai forme e direzione. Il conflitto verticale tra classi superiori e classi subordinate non procede dal basso verso l’alto, ma dall’alto verso il basso. Inaspettatamente si è acceso un micidiale conflitto ridistributivo all’incontrario. Il mondo imprenditoriale, i manager pubblici e privati, le professioni autonome, i ceti superiori – l’inventario è impreciso – hanno beneficiato di un’impressionante ridistribuzione di risorse, mentre una sorda conflittualità orizzontale si registra fra le altre classi, le cui straificazioni interne si sono complicate» (ibi, p. 315).
Per effetto dell’azione combinata di questi fattori, nella «democrazia disorganizzata» le oligarchie finiscono col conquistare un ruolo sempre più significativo, e i «piani alti» dei nostri sistemi democratici tendono a diventare sempre più distanti dai ‘piani bassi’. Ai vertici, si assiste – a tutti i livelli di governo – a una presidenzializzazione che consegna il potere decisionale ai leader eletti, sempre meno vincolati dal controllo delle assemblee rappresentative. Alla base, invece, una molteplicità di associazioni e soggetti più o meno connotati politicamente si contende lo spazio della partecipazione. Forse – osserva Mastropaolo – si tratta delle prime tracce di una nuova ‘divisione del lavoro’, e dunque dei primi segnali di ciò che potrà diventare nel futuro la democrazia, in cui le pratiche deliberative potrebbero avere un ruolo significativo (ibi, pp. 335-337). Ma non è neppure da escludere che si tratti di un’involuzione, e, anzi, l’intreccio di tutte queste tendenze è tale da suggerire quantomeno l’ipotesi che la divaricazione fra «piani alti» e «piani bassi» configuri una vera e propria rivincita delle oligarchie e una trasformazione radicale della dinamica democratica. Come scrive Mastropaolo a questo proposito:
«Ciò invita a concludere chiedendosi se la mutazione che ha investito i regimi democratici non sia per caso paragonabile per la sua portata a quella imposta ai regimi rappresentativi dal suffragio universale, salvo che è di segno opposto. Che non sia in atto una rivincita contro quest’ultimo, senza neanche prendersi il disturbo di revocarlo?» (ibi, p. 338). Il quadro così delineato è quantomeno piuttosto fosco, ma la crisi economica che stiamo vivendo dal 2008 getta un’ombra ancor più sinistra sul nostro futuro. Tanto che Mastropaolo si chiede se davvero la democrazia potrà sopravvivere al declino del benessere materiale, all’aumento delle diseguaglianze sociali, alla crescita del disordine, al mutamento degli equilibri internazionali che le trasformazioni dell’economia mondiale sembrano portarci in dote. Mastropaolo non sposa interamente la tesi della ‘crisi’ della democrazia, e tantomeno l’idea che la democrazia si sia già trasformata in qualcosa di diverso, in un regime autoritario o ‘plutocratico’ travestito di abiti seducenti. Ma, al tempo stesso, riconosce che, dentro il guscio della democrazia contemporanea, si è prodotta una modificazione che autorizza almeno il sospetto che, dietro la continuità formale, dietro la conservazione delle ‘procedure’democratiche (o quantomeno dietro il rispetto di procedure scheletriche), si nasconda di fatto una rottura: «Ciò, a quanto pare, non autorizza a parlare di lesa democrazia. La democrazia delle regole minime è tollerante e può farsi con tanti mezzi. Democrazia si chiamava quella vigente in precedenza, democrazia seguita a chiamarsi quella attuale. Se non che, cambiata la società, disperse di sicuro simbolicamente e politicamente le classi sociali, riaggiustate, senza bisogno di rumorosi sommovimenti, le regole del gioco, i risultati – o le politiche – sono ben altri e altre le gerarchie statali. E l’homo democraticus plasmato dalla cultura individualista e pro-market, nobilitata dai diritti o tempestata dalla società civile e dal comunitarismo Third way, è ben diverso, sul piano normativo e su quello dei comportamenti sociali, da quello forgiato dalle culture politiche di marca solidarista – socialista e non solo – che avevano contrastato in passato la differenziazione e il pluralismo suscitati dalla modernità e dall’industrializzazione. C’è dunque da domandarsi se l’accanimento con cui si difende l’impiego del medesimo termine serva volutamente a occultare una rottura anziché indicarne una continuità» (ibi, p. 341).
In effetti, nella democrazia odierna, secondo Mastropaolo, si cela proprio il «privilegio di pochi» (ibi, p. 341), e inoltre l’attuale riconfigurazione degli equilibri mondiali fa presagire un’ulteriore abbassamento dei livelli di benessere delle società occidentali, con conseguenze non certo positive sui sistemi politici democratici. Così, il politologo – formulando nelle pagine conclusive una previsione segnata da un certo pessimismo – si chiede se la democrazia non sia ormai una «causa persa», nel senso in cui ne parlava Edward E. Said, ossia una causa nobile, ma per cui è ormai del tutto inutile combattere: «se è consentito all’autore di queste pagine avanzare – alla luce dei valori equipaggiato dei quali anch’egli partecipa al complicato gioco democratico, nonché degli strumenti interpretativi di cui dispone – qualche previsione sullo stato futuro del mondo, la sola che verrebbe di fatto di azzardare, è che la democrazia è una causa persa. Anche se resta una causa nobile. I suoi principi ispiratori – la libertà e il rispetto dell’altro – e la sua ambizione di pacificare il conflitto, di contenere e civilizzare il potere e metterlo al servizio della collettività, sono di alto pregio. Purtroppo, le regole democratiche sono quel che sono, cioè imperfette. Da esse, di per se stesse, è arduo cavare più di tanto. Il resto tocca alla politica che, ultimamente, per gran parte dei governanti si è fatta molto avara» (ibi, p. 345). Mastropaolo non rinuncia a riconoscere – già nel nostro presente – i segnali di una possibile inversione di rotta. «Se la condizione attuale delle società democratiche – e del mondo intorno ad esse – è come sempre instabile», scrive infatti il politologo, «come sempre non mancano uomini e donne che non solo ragionano e discutono, ma che sono pure disponibili a incantarsi». A dispetto di tutti quei segnali che inducono a previsioni funeste, diventa così possibile concedere almeno uno spiraglio alla democrazia. Anche perché, come conclude, «se l’ottimismo sovente è fatuo, il pessimismo ancor più spesso è ottuso» (ibi, p. 353).
Democrazia e potere
L’immagine di una democrazia ‘commissariata’ dalla Bce, o la sagoma scheletrica di una politica ‘svuotata’ dal pervasivo potere dei mercati, dicono naturalmente solo una parte della realtà. Non tanto perché – come ha sostenuto per esempio Barbara Spinelli (L’irruzione della realtà, in «la Repubblica», 10 agosto 2011, p. 1) – gli Stati del Vecchio continente abbiano effettivamente e definitivamente rinunciato alla loro sovranità (a meno di non ‘reinventare’ il concetto di sovranità, o di equiparare l’Unione Europea a uno Stato sovrano). Quanto perché proprio una simile rappresentazione finisce col costituire un’attenuante nei confronti dei governi occidentali, i quali – nel momento in cui ritraggono se stessi come semplici esecutori delle direttive delle istituzioni sovranazionali o della volontà un mercato onnipotente e incontrollabile – finiscono di fatto con lo scaricare su altri soggetti ogni responsabilità politica, e prima di tutto la responsabilità di non avere compreso – né ora, né dieci anni fa – la portata della modificazione geo-politica e geo-economica in atto. Il fatto che la rappresentazione di una democrazia ‘svuotata’ dai mercati e di una sovranità insidiata dal potere dell’economia globale sia solo in parte adeguata a comprendere la realtà, non significa però che l’impotenza degli Stati e della politica sia oggi solo l’effetto di una distorsione ottica. Piuttosto, i rapporti fra Stato e mercato, fra politica ed economia, fra la democrazia e ‘globalizzazione’, vanno inseriti in un quadro più ampio, in cui i rapporti economici, gli assetti sociali, le dinamiche istituzionali sono il risultato delle relazioni di potere e del loro mutamento storico. In altri termini – come rileva anche Mastropaolo – persino la democrazia contemporanea può essere considerata come un «armistizio», ma si tratta di un armistizio molto diverso da quello del passato. L’ascesa della finanza e il passaggio a un regime di accumulazione trainato dalla finanza richiedono infatti forme conflittuali radicalmente differenti rispetto alla stagione fordista. In questa transizione, la politica non gioca un ruolo secondario, e non si limita a subire gli effetti della globalizzazione. Gli Stati – e dunque le democrazie occidentali – agiscono con un ruolo di primo piano nel destrutturare l’assetto fordista, e dunque nel superare l’«armistizio» postbellico, per il semplice motivo che questa strada consente – o almeno ha consentito fino a un certo momento – di superare la ‘stagnazione’ e la ‘crisi’ degli anni Settanta. Oggi la fase di ascesa del ‘post-fordismo’ è probabilmente ormai giunta al termine, o quantomeno si sono esauriti i benefici che la finanziarizzazione ha parzialmente consentito, e così si scopre quanto le speranze riposte in una nuova fase di accumulazione fossero in gran parte illusorie. Il punto è però che – dopo questa lunga stagione – sul tappeto non rimane più alcun soggetto capace di esercitare un potere di contrattazione e interdizione all’interno della contrapposizione capitale-lavoro. In altri termini, per quanto esista un nesso fra il lavoro e il capitale finanziario, e dunque fra ‘economia reale’ ed ‘economia finanziaria’, non si tratta di un legame che consente la strutturazione di soggetti conflittuali, e perciò non esistono margini reali per la regolazione delle tensioni sociali. Se da un lato il versante degli interessi imprenditoriali appare frammentato, dall’altro la forza materiale di ciò che rimane del lavoro organizzato, polo cruciale del vecchio assetto fordista, è inadeguata: inadeguata non tanto per pensare il conflitto o per impostare singole vertenze, quanto per ipotizzare una strutturazione del conflitto e una sua regolazione. Così, se l’armistizio che reggeva la democrazia di ieri appare ormai superato in mille direzioni, e se le condizioni interne e internazionali che resero possibile e necessario quell’assetto sono ormai definitivamente tramontate, diventa invece molto difficile ipotizzare se, come e quando si giungerà a un nuovo armistizio. Tanto che risulta impraticabile anche solo pensare quali soggetti potrebbero sedersi al tavolo della tregua (a meno di non credere alle formule rituali della concertazione).
Negli ultimi anni, il dibattito si è spesso soffermato sulle possibilità che offrono le pratiche deliberative. Nel suo recente Democrazie (Il Mulino, Bologna, 2011), Donatella della Porta propone una rassegna di queste posizioni, e soprattutto sostiene che si tratta, forse non di un’alternativa, ma comunque di uno strumento in grado di rispondere alle sfide cui è sottoposta la democrazia liberale rappresentativa. Anche Mastropaolo – come si è visto – prende in considerazione questa ipotesi e valuta persino l’eventualità che l’affermarsi di una sorta di ‘contropotere’ dal basso possa prefigurare un’inedita forma di divisione dei poteri. Ma se nel suo precedente volume La mucca pazza della democrazia (Bollati Boringhieri, Torino, 2005) assegnava a questa ipotesi una maggiore credibilità, oggi pare invece abbandonare alcune delle precedenti speranze. E scrive per esempio che la proliferazione dei fenomeni di ‘auto-organizzazione’ della società civile, mentre punta alla costruzione di spazi di partecipazione oltre i partiti, potrebbe addirittura legittimare l’approfondimento della separazione fra «piani alti» e «piani bassi»:
«Nei regimi democratici tra piani bassi e piani alti il rinnovamento delle procedure ha promosso un singolare processo di dissociazione. Ai piani alti vige la presidenzializzazione, o qualcosa di assimilabile. A loro volta società civile, associazioni, movimenti, istanze deliberative, stake-holders, si disputano accanitamente lo spazio della partecipazione: per la negoziazione spiccia e per la protesta. Solo che ciò avviene prevalentemente ai piani bassi, ma ai piani alti suscita non poco imbarazzo. Potrebbe essere il segno di una divisione del lavoro in via di perfezionamento. La presidenzializzazione semplifica all’estremo l’eterogeneità dei governati intorno al leader da essi eletto. Dal canto opposto, la governance e tutto il resto permettono al popolo – seppur ridotto alle sue parti ritenute politicamente significative – di far sentire le sue tante voci. Il parlamento e il governo locale fanno da riempitivo, seppure non irrilevante, mentre l’atmosfera è impregnata da mille retoriche in contrasto, tra cui quelle dedicate alla trascendenza del collettivo e al protagonismo della cittadinanza. In aggiunta, un po’ di eccitazione antipolitica e pseudopolitica sembra ai governanti così conveniente da promuoverla essi stessi» (A. Mastropaolo, La democrazia è una causa persa?, cit., pp. 337-338). A ben vedere, è molto difficile non condividere il pessimismo di Mastropaolo anche a questo proposito. Non certo perché la richiesta di partecipazione da parte della società o la sperimentazione di pratiche deliberative siano fenomeni deprecabili. Ma perché affidare a strumenti di questo tipo le residue speranze di rivitalizzare la democrazia contemporanea rischia di condurre a una disillusione quasi inevitabile. Per molti versi, sarebbe come pretendere di combattere una guerra opponendo truppe male armate di volontari a un esercito di professionisti ben equipaggiati e dotati di ogni ritrovato tecnologico: forse può consentire una resistenza efficace, forse può persino dare la possibilità di spingere sulla difensiva le truppe avversarie, ma non può certo condurre a uno stabile armistizio, non può portare all’affermazione di un reale equilibrio di poteri. E, soprattutto, non può ‘mettere in forma’ i magmatici conflitti del XXI secolo e i soggetti frammentati che nascono nelle reti e nei flussi del capitalismo cognitivo.
Dinanzi a questa situazione non ci sono soluzioni facili, e cadere nella tentazione dell’anti-politica è quasi inevitabile. Probabilmente, le ondate – comprensibili e giustificabili – di sentimenti antipolitici, di disgusto nei confronti del ceto politico, di ‘indignazione’ nei confronti delle istituzioni finanziarie, non possono dare una spinta reale alla definizione di un ‘armistizio’, capace di dare sostanza alla dinamica democratica, ma rischiano persino di legittimare (più o meno implicitamente) derive opposte. E, sotto questo profilo, Mastropaolo ha ricostruito in modo esemplare gli effetti distruttivi che la seduzione dell’anti-politica ha prodotto sul sistema italiano, a partire dalla retorica del «nuovo che avanza» (cfr. A. Mastropaolo, Antipolitica. All’origine della crisi italiana, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli, 2000). L’unica soluzione – ancora una volta – passa per la ‘porta stretta’ della politica: non di una politica che punti a conquistare posti di potere, ma di una politica che possa ‘esprimere’ potere, che sappia ‘mettere in forma’ i conflitti poggiando sulle basi dell’economia postfordista, prima ancora che di definire le condizioni di un nuovo armistizio.
In questa prospettiva, il lavoro degli intellettuali forse non è proprio del tutto inutile come si è pensato in questi anni, in cui la funzione intellettuale si è limitata allo sgomento commento della «mutazione antropologica», della deriva personalistica, del trionfo del più becero edonismo e della trivialità più oscena, quando non si è ridotta a una semplice funzione ornamentale e alla compiaciuta legittimazione di effimere mode culturali e di disastrose avventure politiche. La democrazia d’altronde – e Mastropaolo l’ha scritto in molte occasioni – è anche il risultato del confronto culturale, ossia dello scontro e della contrapposizione fra immagini diverse del ‘dover essere’ della democrazia, dei diritti e della dignità umana. E proprio per questo – si potrebbe dire utilizzando la formula gramsciana, ripresa da Ernesto Laclau e Chantal Mouffe – la democrazia è in fondo una sagoma vuota, riempita dagli esiti della battaglia per la definizione dell’ordine simbolico, e costantemente ridefinita dai conflitti per l’egemonia. Naturalmente, sarebbe fin troppo semplicistico pensare che gli intellettuali e il lavoro sull’ordine simbolico possano davvero mutare gli assetti egemonici e gli equilibri di potere, senza tener conto delle forze materiali che si muovono nei ‘piani bassi’ della società, nella vita quotidiana, nei luoghi e nei flussi del lavoro contemporaneo. Come, d’altronde, sarebbe una furbesca (o ingenua) semplificazione ritenere che la seduzione di qualche nuova ‘narrazione’ del presente possa invertire le sorti di una trasformazione radicale, o arrestare la marcia della «mutazione antropologica». Ma la strada per ripensare alla possibilità di un nuovo armistizio democratico passa anche dalla capacità di coniugare il pensiero con il potere, l’immaginario con l’organizzazione, la visione e la forza. Perché, forse, la salvezza della democrazia dei posteri richiede davvero una sorta di inedito «Principe postmoderno». Damiano Palano
Alfio Mastropaolo, La democrazia è una causa persa? Paradossi di un’invenzione imperfetta, Bollati Boringhieri, pp. 363, euro 18.00.
martedì 13 marzo 2012
lunedì 27 febbraio 2012
Con NO TAV
Oggi tutti i TG hanno dedicato al “grave incidente in Val di Susa” tutto lo spazio che non hanno mai dedicato alle argomentazioni NO TAV di opposizione all’opera; oggi era indispensabile far passare un messaggio: “un incosciente è salito su un traliccio dell’alta tensione, ha preso la scossa ed è caduto” come a dire che chi se le cerca prima poi le trova
con la consueta rozzezza per cui riesce sempre a spiccare (che evidentemente lo mette però in sintonia coi propri lettori) Libero ha rinunciato al messaggio tra le righe e ha lanciato il sondaggio: “Luca Abbà, il 37enne no-Tav, fulminato su un tralicco mentre protestava: se l'è cercata?” (http://www.liberoquotidiano.it/sondaggio.jsp?idsondaggio=624&idvoto=1814). Dovrebbe sorgere spontanea una domanda: ma se era solo un coglione che se l’è cercata com’è che qualche ora dopo tutta le strade della valle erano bloccate per una reazione spontanea della gente ??? Ho sentito nell’audio registrato da Radio Black Out la voce di una persona eccitata avvisare i soldati (che lo pressavano inseguendolo su per il traliccio) di essere pronto ad attaccarsi ai fili e mi chiedo: per quale ragione quando c’è un cristo che ha deciso di farla finita e sta per buttarsi da un cornicione c’è la fila di santi, eroi e forze dell’ordine a garantirgli che la sua vita da quel momento in poi sarà tutta rose e fiori e a Luca Abbà non hanno concesso neanche il tempo di prendere fiato, di calmarsi un attimo. Bastardi assassini al servizio di uno Stato marcio.
venerdì 24 febbraio 2012
25 Febbraio 2012: Prima Conferenza annuale della Rete dei Comunisti
Dando seguito alle decisioni della terza assemblea nazionale della Rete dei Comunisti, sabato 25 febbraio a Roma si terrà la prima Conferenza annuale che introduce un passaggio nella discussione e nell’elaborazione del percorso politico dell’organizzazione. Alcuni passaggi del documento politico di convocazione della Conferenza nazionale. La Conferenza annuale dei militanti e degli attivisti della Rete dei Comunisti ha l’obiettivo di mettere a bilancio critico il lavoro svolto da aprile dello scorso anno ad oggi e di impostare gli assi strategici del lavoro dei prossimi mesi fino al nuovo appuntamento annuale. “Alla nostra organizzazione serve ormai una discussione profonda e capillare che consenta a tutti i militanti e gli attivisti di avere il quadro generale del funzionamento dell’organizzazione e di come questa agisce concretamente nel conflitto di classe sul piano politico, sindacale, sociale, comunicativo, culturale nella ricostruzione di una soggettività comunista organizzata e attiva” recita il documento politico di convocazione della Conferenza. “Non possiamo nasconderci che il nodo della soggettività, del come una organizzazione comunista agisce effettivamente nella realtà, di come intende far crescere la propria influenza politica e teorica, di come aggrega nuovi militanti e attivisti, di come svolge un ruolo dinamico nel conflitto sociale e nella vita politica del paese (per quanto esso possa essere limitato), rimane il punto da cui far derivare il confronto e la crescita dei compagni e delle compagne che hanno costruito in questi anni la Rete dei Comunisti”. Relativamente al nodo della soggettività, viene annunciato il secondo Forum su “Partito e Organizzazione” in cantiere per primavera, che – secondo la Rete dei Comunisti - consentirà di riprendere e approfondire l’elaborazione politica e teorica avviata e di mettere a confronto con altre tesi la concezione della “funzione di massa” a cui dovrebbe aspirare una organizzazione di quadri comunisti che agisce nella realtà italiana ed europea del XXI Secolo”. Nel documento si riafferma la concezione di un progetto politico che, come è noto, è stato delineato sulla base di tre fronti distinti: strategico, politico e sociale e che “sembra ancora reggere alla verifica della realtà, ma, spesso, non possiamo negare che le accelerazioni della realtà stessa e la accentuata politicizzazione di tutti i processi sociali in corso, costringono a mettere a verifica" "In questo stretta connessione tra teoria e prassi, sta ancora il punto di forza di una esperienza, originale ed inedita anche se confrontata alle stesse modalità classiche del movimento comunista internazionale, come la Rete dei Comunisti”. La prima Conferenza nazionale del 25 febbraio si appresta dunque a discutere molto dell’organizzazione, di come si è strutturata, di come funzionano politicamente le varie strutture e di come hanno agito nei vari settori di lavoro: Il ruolo dei compagni della RdC nel lavoro di massa sociale, sindacale e politico, gli strumenti di comunicazione (giornale, rivista, radio), l’attività internazionalista, la formazione teorica, l’ambiente, l’intervento nel settore giovanile e studentesco ovvero i settori di lavoro decisi alla terza assemblea nazionale della Rete dei Comunisti svoltasi nell'aprile dello scorso anno. Sulla fase politica la Rete dei Comunisti, centra la attenzione soprattutto sulla dimensione europea dei processi incorso ritenendo che sia ormai evidente come “le classi dominanti in Europa stiano utilizzando la crisi in corso per rafforzare tutti gli apparati economici, finanziari, politici e militari per affrontare l’accentuarsi della competizione globale con le altre aree monetarie ed economiche intorno alle quali si vanno ri/definendo i vari poli imperialisti in competizione. L’accelerazione dei processi di concentrazione e centralizzazione politica e finanziaria nell’Unione Europea sono funzionali a questo obiettivo. E’ indubbio che in tale processo un ruolo di punta venga svolto dal grande capitale tedesco che fa convergere intorno a sé i maggiori gruppi capitalisti francesi, italiani e di altri paesi minori, assumendo tendenzialmente le caratteristiche di un capitalismo europeo integrato all’interno e quindi adeguato per “internazionalizzarsi”, anche in forme più aggressive, sul piano globale”. La vicenda greca, secondo la RdC, è indicativa della relazione che il rafforzamento del “centro” imperialista europeo intende stabilire verso i paesi più deboli dell'area. “Come tutti i processi anche questo non avviene linearmente ma attraverso scontri e contraddizioni che dislocano, comunque, in avanti gli obiettivi da raggiungere. L’unica certezza è che persistono aree economicamente più deboli dell’Europa che verranno sacrificate a tutto tondo da questo processo di gerarchizzazione e verticalizzazione dell’Unione Europea. I paesi dell’area dei Piigs sono destinati a diventare una periferia interna con un sistema di salari, condizioni lavorative, welfare state e prezzi ridotti con le liberalizzazioni e la concorrenza selvaggia funzionale alla competizione globale. L’innalzamento relativo degli standard sociali nei paesi dell’Europa dell’Est (anche qui oggi rimesso in discussione dalla crisi) e l’abbassamento di quelli dei Piigs, devono trovare un loro punto di equilibrio al ribasso che consenta al “nucleo duro” europeo di poter disporre di tutti gli strumenti per cercare di ricostruire i margini di accumulazione necessari alla tenuta dell’assetto imperialistico. La destrutturazione delle economie dei Piigs, dei residui della presenza dello Stato nell’economia, ha la necessità di procedere sulla strada delle privatizzazioni e della rottura di ogni rigidità salariale o contrattuale del lavoro”. Netto è il giudizio sul governo Monti, al quale le classi dominante hanno affidato il lavoro sporco. “Occorre segnalare – sostiene il documento politico della RdC - come Monti disponga di un margine di manovra migliore di quello della Merkel e di Sarkozy che devono fare i conti con le elezioni alle porte, mentre Monti – al momento – non ha di questi problemi e non deve rendere conto, almeno immediatamente, a nessun elettorato. Tale “punto di forza” di Monti, è stato sottolineato di recente dal Financial Times ed è alla base della “speciale attenzione” che la stessa amministrazione Usa riserva al primo ministro italiano, il che spiega anche la speciale relazione tra Monti e la Gran Bretagna dentro le storiche e crescenti divaricazioni che questa sta accentuando nel suo rapporto con Francia e Germania sui nuovi Trattati Europei. Se queste osservazioni sono realistiche, significa che lo scenario politico più probabile con cui dovremo fare i conti in Italia nei prossimi mesi, sarà quello di un governo che andrà avanti fino alla fine della legislatura (2013) e che utilizzerà questa condizione di sospensione della democrazia rappresentativa (pienamente legittimata da Napolitano) per avanzare nel “lavoro sporco” sul piano economico e sociale. Il segnale inviato ai sindacati Cgil Cisl Uil sul versante attinente il metodo della concertazione la quale non sarà più interpretata come un passaggio obbligato per i governi, è indicativo”. Una attenzione particolare viene rivolta ai conflitti sociali esplosi di recente in settori diversi da quelli tradizionali del lavoro salariato o organizzati contrattualmente, conflitti che sono la risultante del “processo di destrutturazione delle classi medie, una parte delle quali vengono proiettate verso una condizione di “proletarizzazione” dalle misure fiscali e dalle liberalizzazioni imposte dal governo (taxisti, autotrasportatori, coltivatori diretti, piccoli imprenditori etc.) ma anche dalla brusca restrizione delle politiche del credito da parte del sistema bancario”. Il documento sottolinea anche delle preoccupazioni, perchè “in questi settori investiti dalla crisi e dalle misure imposte dall’Unione Europea, può radicalizzarsi un movimento reazionario di massa che fino a ieri agiva solo sul piano ideologico ed elettorale (questi soggetti erano infatti gran parte del blocco sociale berlusconiano e sono da sempre bacino elettorale della destra), ma che oggi può diventare anche “movimento” nel senso delle piazze, delle strade, del territorio e del “territorio politico e sociale” in cui siamo chiamati ad agire” ragione per cui “senza una analisi chiara e una azione conseguente sul piano politico, sociale e sindacale, tale situazione non può che peggiorare. I ceti medi sono stati “proletarizzati” loro malgrado e sul piano ideologico si rifiuteranno fino all’ultimo minuto di percepirsi come tali e di guardare quindi a possibili alleanze sociali con i lavoratori salariati o con istanze collettive non corporative” soprattutto se a questa “identità spuria e bastarda”, anche sul piano ideologico, non si palesano alternative forti sul profilo identitario, ideologico, organizzato e conflittuale. Secondo la Rete dei Comunisti “La ricostruzione, , un blocco sociale anticapitalista dopo una infernale spirale di competizione al ribasso, dovrà fare i conti con un passato recente di scontri e divaricazioni di interessi, il quale potrà essere superato in avanti solo attraverso una nuova connessione politica e sociale contro i comuni avversari ben oltre ogni nicchia corporativa e/o territoriale”. Sui movimenti come i Forconi la RdC ritiene che “è stato un errore, come ha fatto gran parte della sinistra, esorcizzare i movimenti sociali “spuri” messi in campo in Sicilia o in altre aree dai ceti medi proletarizzati dentro i quali è forte una ideologia reazionaria e individualista. Negli anni ’70 si poteva giocare e si è giocata la carta del movimento operaio organizzato e della sua egemonia nella società. Ma nel XXI Secolo, dopo i decenni delle grandi ristrutturazioni a scala globale, questa carta – e soprattutto la sua egemonia – è stata profondamente destrutturata dalla frammentazione di classe e dal disarmo ideologico introdotto dai partiti della sinistra e da Cgil Cisl Uil”. Nel percorso sul quale la prima Conferenza nazionale della Rete dei Comunisti è chiamata a discutere per delineare l'azione politica dei prossimi mesi, viene ribadito che “non dovremmo discostarci dalla linea di condotta seguita in questi anni e cioè l’eventuale sostegno solo a candidati o liste chiaramente alternative e indipendenti da ogni forma di alleanza e di subalternità con il Pd. La funzione della RdC non può che essere quella di favorire la polarizzazione politica piuttosto che la sua ricomposizione dentro alleanze che hanno corrotto politicamente e culturalmente le esperienze della sinistra alternativa spezzando in più punti la relazione con il blocco sociale anticapitalista”. Sul piano strategico riteniamo che sia ancora del tutto inadeguato il dibattito e il confronto sulla riunificazione delle forze comuniste nel nostro paese. Da un lato si consolida la frammentazione dentro e fuori Prc e PdCI, sia tra correnti sia tra le nuove formazioni che sono nate. Dall’altro questa discussione continua a prescindere da qualsiasi confronto di merito sui nodi strategici, sulle novità intervenute e prescinde da qualsiasi bilancio autocritico. Il fronte della rappresentanza politica continua a offrire spazi reali, accentuati dalla crisi e da come questa scompone, distrugge e ricompone la rappresentanza politica dei settori sociali in lotta per sopravvivere o per affermarsi come egemoni. Da un lato serve accumulare le forze in alleanza con altre soggettività; dall’altro non possiamo che agire affinché un pezzo della sinistra e dei movimenti rompano con il politicismo e sintonizzino la loro azione con i settori popolari sulla base dell’autonomia e dell’indipendenza. Il documento entra poi nel merito delle proposte di lavoro a tutto campo – da quello sindacale a quello metropolitano, dall'attività internazionalista all'informazione. Ma questo attiene al dibattito interno al quale tutti i militanti e gli attivisti vengono chiamati a dare un contributo concreto nella Conferenza nazionale del 25 febbraio.
domenica 5 febbraio 2012
La lunga marcia del "liberismo" e del massacro sociale passa dall'euro
"Se cade anche il muro dell'euro" di Alberto Bagnai - Si segnala un articolo interessante del Prof. Alberto Bagnai (del dipartimento di economia Università Chieti-Pescara) affinché il Comitato No Debito ne tragga le dovute conclusioni. Si riscontra che molti aderenti al movimento sanno pochissimo dei problemi causati dalla moneta unica e quindi, sarebbe utile aprire un dibattito all'interno del movimento, ciò può contribuire a fare chiarezza, per incidere costruttivamente a livello politico, ben consapevoli che il governo Monti è al servizio delle banche e a danno dei lavoratori.
La crisi fa emergere il problema originario dell'euro, da sempre ignorato dai politici: una moneta unica nello spazio economico europeo è insostenibile. La levata di scudi dei politici europei contro i “mercati” è prova di ingenuità o di ipocrisia. La crisi dell’euro non dipende tanto dai “mercati”, quanto dal fatto che adottando l’euro la classe politica ha deliberatamente ignorato l’avviso della maggior parte degli economisti, i quali da tempo avvertono che una moneta unica europea non sarebbe sostenibile. Questa scelta politica ha ragioni ideologiche che è necessario individuare per valutare le possibili vie di uscita dalla crisi. Cosa comporta la rinuncia alle monete (e quindi ai tassi di cambio) nazionali? A chi conviene? E perché? Per chiarirlo ripercorriamo gli snodi della crisi greca. Debito estero e tasso di cambio In teoria per ridurre l’indebitamento estero un paese ha due strade: contenere la spesa o svalutare. Ma i paesi appartenenti a una unione monetaria non possono svalutare: possono solo attuare politiche restrittive. Queste migliorano i conti con l’estero riducendo le importazioni: se la gente ha meno soldi da spendere, spende meno anche in beni esteri. La disoccupazione aumenta, perché se la spesa nazionale cala, alcune imprese devono chiudere. L’aumento dei disoccupati contiene i salari, e col tempo le merci nazionali diventano più convenienti e le esportazioni aumentano: alla domanda nazionale si sostituisce domanda estera, e le cose tornano a posto. Questo è il percorso, non breve, che si prefigura per la Grecia. Anche la svalutazione sostituisce domanda estera a quella nazionale, ma in modo più rapido e meno devastante: svalutando il paese rende immediatamente più costose le merci estere (e ne acquista di meno) e immediatamente più convenienti le proprie (e ne vende di più), “isolando” il mercato del lavoro dallo shock. Questo è quello che ha fatto l’Islanda, che dopo la crisi ha svalutato del 133%. Certo, il gioco non può durare all’infinito. Chi svaluta paga di più le merci importate e quindi importa inflazione, minando la propria competitività. Ma perché usare un solo strumento? Si potrebbe svalutare nel breve periodo e mettere i conti in ordine nel medio. Dal novembre 2008 l’Islanda ha stabilizzato il cambio impegnandosi in un percorso di risanamento: non ci sono stati morti per le strade. C’è stata sì l’eruzione di un vulcano, ma nessuno pensa che dipenda dalla svalutazione (fatto salvo forse qualche funzionario della Bce). Dove sta scritto che un governo deve avere solo uno strumento a disposizione? Maastricht e le zone monetarie ottimali Sta scritto nel trattato di Maastricht. Con la moneta unica i paesi dell’eurozona si sono privati di uno dei due strumenti disponibili per riequilibrare i conti con l’estero, quello più rapido (e quindi più adatto per la gestione delle emergenze): la svalutazione. Potevano permetterselo? Al di là dell’evidenza dei fatti, diamo per una volta agli economisti il merito che spetta loro: il primo a dichiarare che non potevano permetterselo è stato James Meade nel 1958 (sì, cinquantadue anni fa), e i motivi sono stati chiariti nel 1961 da Robert Mundell, che per questo ha preso nel 1999 il premio Nobel. Le condizioni che rendono sostenibile l’adozione di una moneta unica sono quattro: [1] flessibilità di prezzi e salari, [2] mobilità dei fattori di produzione, [3] integrazione delle politiche fiscali e [4] convergenza dei tassi di inflazione. Il loro ruolo è chiaro alla luce del fatto che, come abbiamo chiarito, ai paesi che non possono svalutare rimane solo la strada “lacrime e sangue”. Quest’ultima è meno dolorosa se prezzi e salari reagiscono rapidamente ai “tagli” (la flessibilità al ribasso dei salari ripristina più in fretta la competitività del paese), e se i disoccupati possono trovare lavoro nei paesi membri più fortunati (la mobilità riduce i costi sociali dei tagli).
L’integrazione delle politiche fiscali a livello sopranazionale permette interventi di sostegno delle zone in difficoltà. La convergenza dell’inflazione, poi, è cruciale per la sostenibilità della moneta unica: se in un paese i prezzi crescono più in fretta della media, nel lungo andare le sue esportazioni diminuiranno e il paese accumulerà debito estero. Mezzo secolo di studi mostra che nei paesi dell’eurozona queste quattro condizioni non sussistono: la flessibilità dei prezzi e dei salari e la mobilità del lavoro sono insufficienti, l’integrazione delle politiche fiscali è di là da venire, e circa la convergenza dell’inflazione, ricordiamo che dal 1999 in media tutti i paesi dall’area euro hanno avuto inflazione più alta della Germania (perdendo competitività rispetto ad essa). Il paese che ha retto meglio il confronto è stato la Finlandia (con solo 0.1 punti di inflazione in più). I peggiori sono stati Irlanda (1.7 punti in più), Grecia (1.6), Spagna (1.5) e Portogallo (1.2), il che spiega appunto quanto sta accadendo (perdita di competitività, deficit di bilancia dei pagamenti, accumulazione di debito estero, crisi). Economia e ideologia: le “riforme strutturali” Il trattato di Maastricht ignora le condizioni dettate dalla teoria economica (flessibilità, mobilità, integrazione, convergenza dell’inflazione) e insiste sul debito pubblico (irrilevante per la teoria), con l’intento di propugnare la riduzione del peso dello Stato nell’economia, e di evitare riferimenti alla reale natura del problema. Quale sia lo suggerisce Mario Nuti in un intervento nel suo blog, dove dichiara la sua insofferenza verso il termine “riforma strutturale” che, dice lui, in tempi recenti ha significato soprattutto il trasferimento di potere d’acquisto dai più deboli agli speculatori. Vogliamo fare un passo in più? Ricordiamoci allora che in Italia prima dell’euro non si parlava proprio di “riforme strutturali” (che significano precarietà – pardon, mobilità – del lavoro, perdita di potere d’acquisto dei lavoratori – pardon, flessibilità dei salari). Il perché è chiaro: gli aggiustamenti macroeconomici allora non dovevano inevitabilmente passare per il mercato del lavoro. L’approccio di Mundell non è ideologico: Mundell non dice che i salari devono essere flessibili e i lavoratori devono essere “mobili”. Dice solo che se non lo sono, allora è meglio non costituire una unione monetaria. Il problema di Mundell non è “vendere” il paradigma della “flessibilità” (nel 1961 non se ne parlava), è solo capire in quali condizioni un’unione monetaria è sostenibile. L’approccio di Maastricht viceversa è ideologico. Adottare una moneta unica in un’area nella quale essa non è sostenibile impone surrettiziamente e ideologicamente ai paesi membri una rincorsa affannosa dei requisiti necessari (flessibilità, mobilità, ecc.), presentati come mero dato “tecnico” e non come esplicita scelta politica (e quindi sottratti a un reale dibattito democratico). Non è un caso se i governi che ci hanno imposto l’euro sono passati alla storia come governi “tecnici” (altra parola di cui diffidare). Il crollo del muro La crisi dell’euro è il crollo di un muro ideologico: un secondo muro di Berlino, eretto a difesa della competitività tedesca e dell’ideologia della flessibilità, travolto non tanto dai “mercati”, quanto dall’assenza di razionalità economica. Da anni gli economisti avvertono che nell’eurozona non esistono le condizioni per la sostenibilità di una moneta unica. I politici hanno proceduto per la loro strada, e ora devono gestire le conseguenze della loro scelta. Dare la colpa a generici altri (i “mercati”) non li aiuterà. Agli elettori di sinistra italiani l’adesione all’euro è stata venduta come una vittoria della loro parte politica, dettata dal bisogno di evitare all’Italia il destino dell’Argentina. I dati mostrano che l’Argentina è incorsa in una crisi debitoria a causa della perdita di competitività determinata dalla “dollarizzazione” della sua economia, esattamente come la Grecia è incorsa in una crisi dopo l’“euroizzazione” della sua economia. L’euro è stato causa, non rimedio. La teoria delle zone monetarie ottimali implica che l’euro è stato una vittoria politica di chi desiderava che in Europa gli aggiustamenti macroeconomici si scaricassero integralmente sul mercato del lavoro (traducendosi in “lacrime e sangue”). Vi sembra una vittoria della sinistra?
venerdì 20 gennaio 2012
Fermenti vivi per un epoca nuova
Sono circa trent'anni che la dittatura politico-culturale del capitale multinazionale ("viene al mondo grondante sangue e sporcizia dalla testa ai piedi, da ogni poro", K. Marx, "Il capitale", I, sez. VII, cap. 24) governa l'economia-mondo e le moltitudini in rivolta apprezzano sulla propria pelle quel fumus democratico avvolgente ogni tentativo di cambiamento radicale ed ogni dialettica rivendicativa instauratile con i poteri costituiti. S'attende ancora che la “sollevazione” generi un'altra organizzazione sociale, nuove istituzionalità popolari, nuove forme relazionali di vita e che comprenda un semplice assunto: la preistoria del capitale, la premessa, la condizione di possibilità dell’accumulazione capitalistica, cioè l’accumulazione originaria, è la separazione del produttore dai mezzi di produzione. L’accumulazione del capitale presuppone infatti il plusvalore, che a sua volta esige l’esistenza della produzione capitalistica, le cui ineliminabili premesse sono la presenza, da un lato di ingenti masse di capitali, e dall’altro di considerevoli quantità di forza lavoro a disposizione dei produttori di merci. Questo è il processo di produzione capitalistico che si presenta, descritto alla fine del libro I del Capitale di Marx, come un meccanismo che si autoriproduce, capace di autoalimentarsi all'infinito. Vale la pena qui ricordare che l’accumulazione originaria negli U.S.A. s'affermò anche con la prima generazione capitalistica dei “robber baron” letteralmente “grandi rapinatori”; questa storia ha origine a partire dagli anni ’30 dell’Ottocento, nella creazione delle prime banche di investimenti, cioè le prime Banche d’affari private che potevano utilizzare il proprio capitale per le operazioni finanziarie senza alcuna autorizzazione statale; il principio su cui tali banche si svilupparono rapidamente e crebbero fino ai giorni nostri è in fondo semplice oltre che banale, vecchio come il mondo: la truffa. In pratica si vendevano titoli senza la copertura finanziaria dell’acquisto, si vendevano titoli non acquistati. Tutta la storia economica americana è fatta di queste truffe che dettero comunque grande impulso alla nascente economia, con grandi risorse finanziarie messe a disposizioni per nuovi investimenti da cui ebbero origine le attuali Banche d’affari che determinano le sorti economiche del mondo. Inoltre, non dimentichiamo che il termine democrazia deriva dal greco δῆμος (démos): popolo e κράτος (cràtos): potere. Non c'è “sollevazione” antagonistico-sociale che annunci un'epoca nuova senza che si apra la prospettiva di un “potere altro” rispetto al dominio globale del capitale multinazionale. "… Al tempo stesso, proprio la grande sconfitta è per i partiti rivoluzionari e per la classe rivoluzionaria una lezione effettiva e molto utile, una lezione di dialettica storica, una lezione che fa loro capire ed apprendere l’arte di condurre la lotta politica”. Ad oltre tre decenni dal dilagare del “liberismo”, dalla deregulation delle democrazie occidentali e dallo smantellamento del Welfare residuale, si dà non più solo come necessario ma anche possibile un bilancio autocritico dell'esperienza dell'insubordinazione sociale, anche alla luce delle contraddizioni insite nelle stesse lotte di liberazione dei popoli nordafricani e del variegato “movimento NO debito” occidentale, al fine di rilanciare una teoria-prassi rivoluzionaria che, nel vivo dello scontro, matura grazie anche alla consapevolezza degli errori commessi. Una spietata riflessione su questi errori è richiesta non solo dalla portata della sconfitta ma dalla consapevolezza che una seconda prova d’appello è preclusa, perché non sarebbe altro che la riproposizione farsesca di quelle esperienze che non sanno alludere alla questione del “potere”. Per questo, nel definire i termini dell’autocritica, vanno evitati due errori: 1) riproporre sotto altre forme la sostanza di un impianto già verificatosi fallimentare; 2) ricercare un impianto corretto sotto forma di esercizio di purismo teorico astratto, non vincolato all’adeguatezza di una verifica storica. In questo senso, stanare gli errori e i vizi di ragionamenti antidialettici, antimaterialisti, quindi idealisti, va perseguito col massimo rigore a partire dai principi del marxismo leninismo e dall’esperienza storica teorico-pratica fin qui acquisita dal marxismo applicato alla rivoluzione dei rapporti sociali.
Le forze dirompenti dell'antagonismo sociale rinascono in Italia dopo 30 anni di relativa pace sociale caratterizzati dal ciclo espansivo del capitale dopo il secondo conflitto mondiale e dalla gestione legalista dell’antagonismo proletario da parte delle organizzazioni politico-sindacali “collaborazioniste”, tesa a perpetuare una condizione di conciliabilità tra interessi di classe che permettesse la legittimazione democraticista del “conflitto” e, conseguentemente, della stessa collocazione quali forze politiche “democratiche” - espressione “neutra” del mondo del lavoro - progressivamente inseribili nell’arco delle forze di governo. Al di là di pure enunciazioni propagandistiche, la “via nazionale al socialismo” costituisce l’elaborazione teorica del tentativo storico del revisionismo di smantellare una volta per tutte ogni “velleità” di trasformazione rivoluzionaria della società. La rivoluzione proletaria per i partiti revisionisti che avevano rotto col marxismo rivoluzionario e portato a degenerazione reazionaria le contraddizioni della politica dei “due tempi” della Terza Internazionale, non solo non era più possibile, ma neanche necessaria. Le “acute” riflessioni di Berlinguer all’indomani del colpo di stato in Cile e l’accelerazione della politica di alleanza con la DC, sono degne figlie della rottura operata dal PCI sotto la guida di Togliatti, in cui inizia un processo di sostanziale sproletarizzazione di questo partito che costituisce la base materiale di tutta la successiva maturazione e collocazione in termini filoccidentali e socialdemocratici anche di tutte le successive diaspore e riorganizzazioni legalitario-parlamentari sotto le effigi del “comunismo” variamente declinato e rappresentato. Alla fine degli anni ’60 si vive una situazione politico-sociale di grande trasformazione, una composizione di classe drasticamente mutata, un relativo benessere materiale, una inusitata mobilità socio-culturale ed una ristrutturazione effettiva della tradizionale stratificazione di classe. S'assiste, nel contempo, al coagularsi di diverse contraddizioni: uno scenario internazionale violentemente scosso da conflitti locali che assumevano il carattere di liberazione nazionale antimperialista; il consolidamento della dittatura del proletariato in Cina che assumeva, con l'avvio della “rivoluzione culturale”, una sua peculiare, storicamente inedita, manifestazione; la ricerca conflittuale di un nuovo equilibrio nella spartizione del mondo tra i due blocchi imperialisti principali e l'entrata in crisi della “coesistenza pacifica”; termine ed involuzione dell’ondata espansiva del ciclo capitalistico; il congiungersi di un’ondata di antagonismo operaio e proletario nelle metropoli occidentali con i preesistenti conflitti che caratterizzavano il difficile rapporto centro imperialista – periferia. Nei paesi capitalisti un “modello di sviluppo” evidenzia la correlata, fisiologica “tendenza naturale” ad entrare in “crisi” aprendosi ad una congiuntura favorevole alla lotta di classe alle cui caratteristiche anticapitalistiche si aggiunge un profondo “sentimento” antistatunitense, suscitato soprattutto dall’eroica guerra di liberazione del Vietnam. Nella metropoli italiana, l’estensione, la maturità, la durata e il carattere fortemente proletario espressi in quel ciclo di lotte, costituiscono la condizione per il costituirsi di un movimento autenticamente rivoluzionario. La sostanza politica della mobilitazione del fronte proletario in quegli anni, affermava la profonda consapevolezza della critica al modo di produzione capitalistico e al revisionismo, dando prova concreta di una riaffermata capacità di espressione di autentica autonomia di classe. Tra le avanguardie più coscienti, il dibattito verte intorno alla questione dell’organizzazione rivoluzionaria e di una teoria-prassi della rivoluzione proletaria nei paesi imperialisti. L’antiparlamentarismo ne costituisce il comune denominatore; il marxismo leninismo rivoluzionario la discriminante di fondo. In questa situazione le esperienze dell'antagonismo sociale muovono a configurare oggettivamente prassi organizzate in grado di compiere (emancipandosi definitivamente dal velleitarismo soggettivistico e dall'ambiguità pacifismo “equidistante”) l’effettiva rottura storica del quadro politico strutturale, mettendo in pratica la sostanza dell’alternativa proletaria rivoluzionaria al sistema politico borghese dei partiti sul piano del marxismo leninismo, pur negli evidenti limiti di un’esperienza originale. La proposta non può che essere di natura strategica - la lotta per il comunismo - come unica condizione per fare politica rivoluzionaria in quest’epoca storica e dare prospettiva e sbocco alla lotta delle masse. Le organizzazioni che si muovono su questo terreno propongono quindi uno sviluppo del processo rivoluzionario proletario, necessariamente originale, dato che ritengono possibile e necessario, in una situazione non rivoluzionaria, dare inizio a un processo di “guerra di lunga durata” caratterizzata dal conflitto sociale in tutte le forme che l'ostilità classista nelle metropoli del capitale richiede. Non solo avviene la rottura con la concezione insurrezionale terzointernazionalista, ma è posto all'ordine del giorno l'impossibilità in ogni caso della riproposizione di un lavoro di accumulo di coscienza e di organizzazione rivoluzionaria prima, per impiegarla poi anche in termini dirompenti in un ristretto arco di tempo. L'organizzazione del conflitto sociale per la conquista del potere viene concepita come una strategia rivoluzionaria perché la sola che mette in grado di muoversi sul terreno rivoluzionario, di potere, sfruttando le contraddizioni che apre nei confronti dello Stato, costringendolo a liberarsi di ogni velo di neutralità e a materializzare la sua natura di classe; a rompere il gioco paralizzante (per il proletariato) dell’altalena repressione-riforme, funzionale al rafforzamento del potere della borghesia. L’agire politico antagonistico-sociale organizzato dei comunisti apre la fase rivoluzionaria a partire da una progettualità rivolta, inizialmente, alle avanguardie in stretta dialettica con i contenuti di potere espressi dalle lotte oggettivamente e dai settori più avanzati della classe anche soggettivamente, per rappresentarne gli interessi generali e dare prospettiva concreta all’interesse storico di alternativa rivoluzionaria di potere. In questo senso, è applicato uno dei presupposti fondamentali del marxismo rivoluzionario, consapevoli che “il progresso rivoluzionario non si fece strada con le sue tragicomiche conquiste immediate ma al contrario, facendo sorgere una controrivoluzione potente, serrata, facendo sorgere un avversario, combattendo il quale soltanto il partito dell’insurrezione raggiunse la maturità di un vero partito rivoluzionario”.
Il problema centrale per dei marxisti non è dunque la propaganda del carattere borghese e di classe dello Stato, bensì l’attrezzarsi teoricamente-organizzativamente e strategicamente a dirigere lo scontro col nemico di classe, in condizioni favorevoli affinché questo scontro possa essere iniziato e sostenuto. Ossia che si dia un livello tale della lotta di classe che generi avanguardie comuniste rivoluzionarie organizzate che si rendano disponibili ad agire come rivoluzionari di professione, come reparti d’avanguardia del proletariato. Per quanto ci è dato constatare dalla stessa esperienza dei decenni trascorsi, l’estensione e il radicamento della lotta antagonistico-sociale per il comunismo sono dati dal livello di coscienza complessiva espressa dal proletariato metropolitano che rende possibile e sostiene una forza organizzata rivoluzionaria, che si contrappone in modo riconoscibile allo Stato. Questo, sia in presenza che in assenza di forti movimenti di massa, perché una strategia rivoluzionaria trova legittimità, non come prolungamento naturale della lotta spontanea, ma come risoluzione teorico-pratica della questione del potere, come sedimentazione organizzativa del livello di coscienza di classe che punta alla trasformazione rivoluzionaria dello stato di cose presenti. Ovvio è che questo processo richiede uno svolgimento secondo tappe precise, che determinano i compiti congiunturali dei comunisti nel perseguimento del primo obiettivo del processo rivoluzionario: la conquista del potere politico e la dittatura del proletariato. In questo senso il grado d’incidenza dell’agire dell'organizzazione nella dinamica dello scontro di classe vive dentro condizioni oggettive e soggettive molto precise da cui è impossibile sfuggire, pena il cadere nel pantano del soggettivismo e quindi nella sconfitta.
È necessario chiarire che l'impostazione politica adottata non concepisce la lotta antagonistico-sociale come mero “uso delle armi” in termini propagandistici come strumento politico dell’educazione delle masse circa la necessità della rivoluzione violenta, come strumento più efficace di alcuni perché è impossibile che lo si ignori, sia da parte dello Stato che da parte del proletariato. E questo perché se si pensa ad uno scontro cruento ristretto nel tempo in condizioni eccezionali, non ha nessuna legittimità e senso politico iniziare a combattere quando queste condizioni non ci sono. Sia chiaro che qui non si sta parlando dello scontro, ma della strategia politica che può permettere di conquistare rapporti di forza generali favorevoli, tali da mettere il proletariato rivoluzionario in posizione dominante rispetto alla borghesia e allo Stato. L’offensiva finale, presumibilmente, è necessariamente ristretta nel tempo, perché questa può essere sferrata solo in condizioni di particolare debolezza e di crisi economica, politica e militare dello Stato molto acuta, nonché di una congiuntura internazionale favorevole. E tutto questo non si presenta certo tutti i giorni. Ma se la lotta antagonistico-sociale organizzata acquista valore di strumento propagandistico o dobbiamo dire che essa deve essere praticata esclusivamente a “legittima difesa” in particolarissime condizioni o bisogna pensare possibile attaccare lo Stato, facendo finta di non attaccarlo, evitando “furbescamente” ogni rispetto delle leggi che una guerra ha, per quanto “particolare” essa sia. Perché se si ritiene che la conquista del potere politico possa avvenire in una versione, se pur aggiornata, dell’insurrezione, non si tiene conto di condizioni mutate che la rendono oggi improponibile. E questo per una serie di motivi: a) Il sistema democratico borghese giunto a livello maturo di consolidamento (forma istituzionale adeguata alla estensione e penetrazione raggiunta dal modo di produzione capitalistico a livello sociale e mondiale) è in grado di assorbire le spinte più antagoniste della lotta di classe in un ambito complesso e sofisticato di mediazioni politiche-economiche e militari da cui risulta la capacità della classe al potere di “istituzionalizzare” il conflitto di classe, pur tra lacerazioni e sussulti di un equilibrio sempre precario. b) La controrivoluzione preventiva come politica costante, come dato strutturale tesa a impedire ogni convergenza tra interessi proletari e progetto rivoluzionario. Questa non è materializzabile semplicemente nell’agire della magistratura o nella repressione poliziesca, ma è capacità da parte dello Stato di dosare mediazione e annientamento, distruggendo sul nascere, in forma politica-ideologica-militare, la legittimità stessa della rivoluzione proletaria. c) L’integrazione a tutti i livelli, pur nelle reciproche autonomie e interessi che la rendono sempre contraddittoria e sempre alla ricerca di nuovi equilibri, della catena imperialista in cui il nostro paese è collocato ed il carattere stesso dell’imperialismo che considera vitale per la sua sopravvivenza ogni angolo del mondo. Questa integrazione, per le caratteristiche strutturali dello stadio raggiunto dal capitale monopolistico multinazionale, fa sì che ogni Stato-membro ne interiorizza gli interessi comuni, o meglio colloca i suoi all’interno del rafforzamento di tutta la catena; e non ultimi sono quelli della difesa comune contro il proletariato e contro i popoli dei paesi dipendenti. Queste caratteristiche fanno sì che il problema principale non sia tanto quello di propagandare nelle masse il carattere classista della società ed educarle alla necessità della rivoluzione violenta quanto quello di dimostrare la validità e la praticabilità di un progetto rivoluzionario che punta ad una alternativa di potere, mettendo al centro gli interessi del proletariato metropolitano e di quello internazionale. E questo principalmente perché, nonostante l’uso della mediazione politica, del relativo benessere, e della democraticità delle libertà costituzionali, i contrattacchi dello Stato sono comunque indirizzati all’annientamento di ogni tentativo proletario di trasformare l’antagonismo in movimento rivoluzionario per il potere. Pensare che queste condizioni si possano creare di un colpo, senza uno scontro prolungato nel tempo con lo Stato, contraddistinto da una dinamica “a salti” rispetto al mutare delle condizioni soggettive ed oggettive, significa credere possibile che la borghesia possa convivere con una pratica d’avanguardia sul terreno della politica d’avanguardia che incida sempre più profondamente nella dinamica dello scontro tra le classi, senza che le lacerazioni prodotte da questo stato di cose non la costringa ad attaccare direttamente tutte quelle lotte e quegli organismi organizzati della classe che, volenti o nolenti, coscienti o meno, per essere autenticamente fondati sugli interessi proletari, trovano nella politica rivoluzionaria dei comunisti la sola ed unica direzione e prospettiva. E allora se la lotta antagonistico-sociale dei comunisti non assume la funzione di strategia politica per il processo rivoluzionario del proletariato, le lotte e le mobilitazioni spontanee non possono che arretrare e subire l’inevitabile contrattacco nemico, private della direzione e degli obiettivi necessari. Questo, la classe l’ha già sperimentato tutte le volte che ha conosciuto la faccia vera della dittatura democratica della borghesia, sotto forma di carcere, bombe terroristiche di Stato, repressione violenta di manifestazioni di piazza, licenziamenti politici di massa, smantellamento di intere strutture organizzate “d’opposizione”. Tutte queste cose sono servite a sancire nella pratica le regole del gioco per cui gli interessi dello Stato democratico e le conquiste e i “valori” della civiltà occidentale sono la base di un patto sociale che non può essere messo in discussione e con esso nemmeno la legittimità del potere della borghesia. E questo non è stato determinato da una sorta di imposizione ideologica dello Stato e dei revisionisti che hanno reso il proletariato indisponibile alla comprensione e alla accettazione di un livello di scontro “che vada fino in fondo”, per cui basta propagandare la necessità per liberare forze proletarie dal contenimento coatto che ne fanno la borghesia e il revisionismo. Occorre dimostrare che, nell’aggravarsi della crisi economica e politica della borghesia, esiste un’alternativa rivoluzionaria e proletaria alla crisi dell’imperialismo che può trasformare i progetti antiproletari e guerrafondai del nemico di classe in processi rivoluzionari per la distruzione dello Stato e la conquista del potere politico. Lo stato di pacificazione che la borghesia s’è assicurata nei paesi più forti della catena è la dimostrazione più chiara di come la risoluzione delle ondate antagoniste e cicli di lotte, anche violenti, sul terreno economico sia possibile dentro un quadro di compatibilità con le esigenze capitalistiche e gli interessi borghesi. E questo nonostante fatti concreti che dimostrano quale futuro l’imperialismo offra al proletariato internazionale: una nuova guerra mondiale. In questo quadro la lotta autenticamente orientata far generare il comunismo non è lo strumento propagandistico per poi poterla fare, non è l’ultima forma di lotta propria della fase conclusiva dello scontro, ma la strategia che guida dall’inizio alla fine lo scontro necessariamente prolungato con l’apparato statale borghese. Tale tipologia di lotta si colloca all’interno dell’esperienza del proletariato internazionale e soprattutto del marxismo rivoluzionario che, coll’evolvere delle forme di dominio dello Stato e dell’imperialismo ha trovato e trova all’interno dello scontro di classe le ipotesi rivoluzionarie più adeguate per il raggiungimento dei propri obiettivi. Fermenti vivi per un'epoca nuova.
[Per consultazione: http://www.criticamente.com/marxismo/capitale/capitale_1/Marx_Karl_-_Il_Capitale_-_Libro_I_-_24.htm]
Le forze dirompenti dell'antagonismo sociale rinascono in Italia dopo 30 anni di relativa pace sociale caratterizzati dal ciclo espansivo del capitale dopo il secondo conflitto mondiale e dalla gestione legalista dell’antagonismo proletario da parte delle organizzazioni politico-sindacali “collaborazioniste”, tesa a perpetuare una condizione di conciliabilità tra interessi di classe che permettesse la legittimazione democraticista del “conflitto” e, conseguentemente, della stessa collocazione quali forze politiche “democratiche” - espressione “neutra” del mondo del lavoro - progressivamente inseribili nell’arco delle forze di governo. Al di là di pure enunciazioni propagandistiche, la “via nazionale al socialismo” costituisce l’elaborazione teorica del tentativo storico del revisionismo di smantellare una volta per tutte ogni “velleità” di trasformazione rivoluzionaria della società. La rivoluzione proletaria per i partiti revisionisti che avevano rotto col marxismo rivoluzionario e portato a degenerazione reazionaria le contraddizioni della politica dei “due tempi” della Terza Internazionale, non solo non era più possibile, ma neanche necessaria. Le “acute” riflessioni di Berlinguer all’indomani del colpo di stato in Cile e l’accelerazione della politica di alleanza con la DC, sono degne figlie della rottura operata dal PCI sotto la guida di Togliatti, in cui inizia un processo di sostanziale sproletarizzazione di questo partito che costituisce la base materiale di tutta la successiva maturazione e collocazione in termini filoccidentali e socialdemocratici anche di tutte le successive diaspore e riorganizzazioni legalitario-parlamentari sotto le effigi del “comunismo” variamente declinato e rappresentato. Alla fine degli anni ’60 si vive una situazione politico-sociale di grande trasformazione, una composizione di classe drasticamente mutata, un relativo benessere materiale, una inusitata mobilità socio-culturale ed una ristrutturazione effettiva della tradizionale stratificazione di classe. S'assiste, nel contempo, al coagularsi di diverse contraddizioni: uno scenario internazionale violentemente scosso da conflitti locali che assumevano il carattere di liberazione nazionale antimperialista; il consolidamento della dittatura del proletariato in Cina che assumeva, con l'avvio della “rivoluzione culturale”, una sua peculiare, storicamente inedita, manifestazione; la ricerca conflittuale di un nuovo equilibrio nella spartizione del mondo tra i due blocchi imperialisti principali e l'entrata in crisi della “coesistenza pacifica”; termine ed involuzione dell’ondata espansiva del ciclo capitalistico; il congiungersi di un’ondata di antagonismo operaio e proletario nelle metropoli occidentali con i preesistenti conflitti che caratterizzavano il difficile rapporto centro imperialista – periferia. Nei paesi capitalisti un “modello di sviluppo” evidenzia la correlata, fisiologica “tendenza naturale” ad entrare in “crisi” aprendosi ad una congiuntura favorevole alla lotta di classe alle cui caratteristiche anticapitalistiche si aggiunge un profondo “sentimento” antistatunitense, suscitato soprattutto dall’eroica guerra di liberazione del Vietnam. Nella metropoli italiana, l’estensione, la maturità, la durata e il carattere fortemente proletario espressi in quel ciclo di lotte, costituiscono la condizione per il costituirsi di un movimento autenticamente rivoluzionario. La sostanza politica della mobilitazione del fronte proletario in quegli anni, affermava la profonda consapevolezza della critica al modo di produzione capitalistico e al revisionismo, dando prova concreta di una riaffermata capacità di espressione di autentica autonomia di classe. Tra le avanguardie più coscienti, il dibattito verte intorno alla questione dell’organizzazione rivoluzionaria e di una teoria-prassi della rivoluzione proletaria nei paesi imperialisti. L’antiparlamentarismo ne costituisce il comune denominatore; il marxismo leninismo rivoluzionario la discriminante di fondo. In questa situazione le esperienze dell'antagonismo sociale muovono a configurare oggettivamente prassi organizzate in grado di compiere (emancipandosi definitivamente dal velleitarismo soggettivistico e dall'ambiguità pacifismo “equidistante”) l’effettiva rottura storica del quadro politico strutturale, mettendo in pratica la sostanza dell’alternativa proletaria rivoluzionaria al sistema politico borghese dei partiti sul piano del marxismo leninismo, pur negli evidenti limiti di un’esperienza originale. La proposta non può che essere di natura strategica - la lotta per il comunismo - come unica condizione per fare politica rivoluzionaria in quest’epoca storica e dare prospettiva e sbocco alla lotta delle masse. Le organizzazioni che si muovono su questo terreno propongono quindi uno sviluppo del processo rivoluzionario proletario, necessariamente originale, dato che ritengono possibile e necessario, in una situazione non rivoluzionaria, dare inizio a un processo di “guerra di lunga durata” caratterizzata dal conflitto sociale in tutte le forme che l'ostilità classista nelle metropoli del capitale richiede. Non solo avviene la rottura con la concezione insurrezionale terzointernazionalista, ma è posto all'ordine del giorno l'impossibilità in ogni caso della riproposizione di un lavoro di accumulo di coscienza e di organizzazione rivoluzionaria prima, per impiegarla poi anche in termini dirompenti in un ristretto arco di tempo. L'organizzazione del conflitto sociale per la conquista del potere viene concepita come una strategia rivoluzionaria perché la sola che mette in grado di muoversi sul terreno rivoluzionario, di potere, sfruttando le contraddizioni che apre nei confronti dello Stato, costringendolo a liberarsi di ogni velo di neutralità e a materializzare la sua natura di classe; a rompere il gioco paralizzante (per il proletariato) dell’altalena repressione-riforme, funzionale al rafforzamento del potere della borghesia. L’agire politico antagonistico-sociale organizzato dei comunisti apre la fase rivoluzionaria a partire da una progettualità rivolta, inizialmente, alle avanguardie in stretta dialettica con i contenuti di potere espressi dalle lotte oggettivamente e dai settori più avanzati della classe anche soggettivamente, per rappresentarne gli interessi generali e dare prospettiva concreta all’interesse storico di alternativa rivoluzionaria di potere. In questo senso, è applicato uno dei presupposti fondamentali del marxismo rivoluzionario, consapevoli che “il progresso rivoluzionario non si fece strada con le sue tragicomiche conquiste immediate ma al contrario, facendo sorgere una controrivoluzione potente, serrata, facendo sorgere un avversario, combattendo il quale soltanto il partito dell’insurrezione raggiunse la maturità di un vero partito rivoluzionario”.
Il problema centrale per dei marxisti non è dunque la propaganda del carattere borghese e di classe dello Stato, bensì l’attrezzarsi teoricamente-organizzativamente e strategicamente a dirigere lo scontro col nemico di classe, in condizioni favorevoli affinché questo scontro possa essere iniziato e sostenuto. Ossia che si dia un livello tale della lotta di classe che generi avanguardie comuniste rivoluzionarie organizzate che si rendano disponibili ad agire come rivoluzionari di professione, come reparti d’avanguardia del proletariato. Per quanto ci è dato constatare dalla stessa esperienza dei decenni trascorsi, l’estensione e il radicamento della lotta antagonistico-sociale per il comunismo sono dati dal livello di coscienza complessiva espressa dal proletariato metropolitano che rende possibile e sostiene una forza organizzata rivoluzionaria, che si contrappone in modo riconoscibile allo Stato. Questo, sia in presenza che in assenza di forti movimenti di massa, perché una strategia rivoluzionaria trova legittimità, non come prolungamento naturale della lotta spontanea, ma come risoluzione teorico-pratica della questione del potere, come sedimentazione organizzativa del livello di coscienza di classe che punta alla trasformazione rivoluzionaria dello stato di cose presenti. Ovvio è che questo processo richiede uno svolgimento secondo tappe precise, che determinano i compiti congiunturali dei comunisti nel perseguimento del primo obiettivo del processo rivoluzionario: la conquista del potere politico e la dittatura del proletariato. In questo senso il grado d’incidenza dell’agire dell'organizzazione nella dinamica dello scontro di classe vive dentro condizioni oggettive e soggettive molto precise da cui è impossibile sfuggire, pena il cadere nel pantano del soggettivismo e quindi nella sconfitta.
È necessario chiarire che l'impostazione politica adottata non concepisce la lotta antagonistico-sociale come mero “uso delle armi” in termini propagandistici come strumento politico dell’educazione delle masse circa la necessità della rivoluzione violenta, come strumento più efficace di alcuni perché è impossibile che lo si ignori, sia da parte dello Stato che da parte del proletariato. E questo perché se si pensa ad uno scontro cruento ristretto nel tempo in condizioni eccezionali, non ha nessuna legittimità e senso politico iniziare a combattere quando queste condizioni non ci sono. Sia chiaro che qui non si sta parlando dello scontro, ma della strategia politica che può permettere di conquistare rapporti di forza generali favorevoli, tali da mettere il proletariato rivoluzionario in posizione dominante rispetto alla borghesia e allo Stato. L’offensiva finale, presumibilmente, è necessariamente ristretta nel tempo, perché questa può essere sferrata solo in condizioni di particolare debolezza e di crisi economica, politica e militare dello Stato molto acuta, nonché di una congiuntura internazionale favorevole. E tutto questo non si presenta certo tutti i giorni. Ma se la lotta antagonistico-sociale organizzata acquista valore di strumento propagandistico o dobbiamo dire che essa deve essere praticata esclusivamente a “legittima difesa” in particolarissime condizioni o bisogna pensare possibile attaccare lo Stato, facendo finta di non attaccarlo, evitando “furbescamente” ogni rispetto delle leggi che una guerra ha, per quanto “particolare” essa sia. Perché se si ritiene che la conquista del potere politico possa avvenire in una versione, se pur aggiornata, dell’insurrezione, non si tiene conto di condizioni mutate che la rendono oggi improponibile. E questo per una serie di motivi: a) Il sistema democratico borghese giunto a livello maturo di consolidamento (forma istituzionale adeguata alla estensione e penetrazione raggiunta dal modo di produzione capitalistico a livello sociale e mondiale) è in grado di assorbire le spinte più antagoniste della lotta di classe in un ambito complesso e sofisticato di mediazioni politiche-economiche e militari da cui risulta la capacità della classe al potere di “istituzionalizzare” il conflitto di classe, pur tra lacerazioni e sussulti di un equilibrio sempre precario. b) La controrivoluzione preventiva come politica costante, come dato strutturale tesa a impedire ogni convergenza tra interessi proletari e progetto rivoluzionario. Questa non è materializzabile semplicemente nell’agire della magistratura o nella repressione poliziesca, ma è capacità da parte dello Stato di dosare mediazione e annientamento, distruggendo sul nascere, in forma politica-ideologica-militare, la legittimità stessa della rivoluzione proletaria. c) L’integrazione a tutti i livelli, pur nelle reciproche autonomie e interessi che la rendono sempre contraddittoria e sempre alla ricerca di nuovi equilibri, della catena imperialista in cui il nostro paese è collocato ed il carattere stesso dell’imperialismo che considera vitale per la sua sopravvivenza ogni angolo del mondo. Questa integrazione, per le caratteristiche strutturali dello stadio raggiunto dal capitale monopolistico multinazionale, fa sì che ogni Stato-membro ne interiorizza gli interessi comuni, o meglio colloca i suoi all’interno del rafforzamento di tutta la catena; e non ultimi sono quelli della difesa comune contro il proletariato e contro i popoli dei paesi dipendenti. Queste caratteristiche fanno sì che il problema principale non sia tanto quello di propagandare nelle masse il carattere classista della società ed educarle alla necessità della rivoluzione violenta quanto quello di dimostrare la validità e la praticabilità di un progetto rivoluzionario che punta ad una alternativa di potere, mettendo al centro gli interessi del proletariato metropolitano e di quello internazionale. E questo principalmente perché, nonostante l’uso della mediazione politica, del relativo benessere, e della democraticità delle libertà costituzionali, i contrattacchi dello Stato sono comunque indirizzati all’annientamento di ogni tentativo proletario di trasformare l’antagonismo in movimento rivoluzionario per il potere. Pensare che queste condizioni si possano creare di un colpo, senza uno scontro prolungato nel tempo con lo Stato, contraddistinto da una dinamica “a salti” rispetto al mutare delle condizioni soggettive ed oggettive, significa credere possibile che la borghesia possa convivere con una pratica d’avanguardia sul terreno della politica d’avanguardia che incida sempre più profondamente nella dinamica dello scontro tra le classi, senza che le lacerazioni prodotte da questo stato di cose non la costringa ad attaccare direttamente tutte quelle lotte e quegli organismi organizzati della classe che, volenti o nolenti, coscienti o meno, per essere autenticamente fondati sugli interessi proletari, trovano nella politica rivoluzionaria dei comunisti la sola ed unica direzione e prospettiva. E allora se la lotta antagonistico-sociale dei comunisti non assume la funzione di strategia politica per il processo rivoluzionario del proletariato, le lotte e le mobilitazioni spontanee non possono che arretrare e subire l’inevitabile contrattacco nemico, private della direzione e degli obiettivi necessari. Questo, la classe l’ha già sperimentato tutte le volte che ha conosciuto la faccia vera della dittatura democratica della borghesia, sotto forma di carcere, bombe terroristiche di Stato, repressione violenta di manifestazioni di piazza, licenziamenti politici di massa, smantellamento di intere strutture organizzate “d’opposizione”. Tutte queste cose sono servite a sancire nella pratica le regole del gioco per cui gli interessi dello Stato democratico e le conquiste e i “valori” della civiltà occidentale sono la base di un patto sociale che non può essere messo in discussione e con esso nemmeno la legittimità del potere della borghesia. E questo non è stato determinato da una sorta di imposizione ideologica dello Stato e dei revisionisti che hanno reso il proletariato indisponibile alla comprensione e alla accettazione di un livello di scontro “che vada fino in fondo”, per cui basta propagandare la necessità per liberare forze proletarie dal contenimento coatto che ne fanno la borghesia e il revisionismo. Occorre dimostrare che, nell’aggravarsi della crisi economica e politica della borghesia, esiste un’alternativa rivoluzionaria e proletaria alla crisi dell’imperialismo che può trasformare i progetti antiproletari e guerrafondai del nemico di classe in processi rivoluzionari per la distruzione dello Stato e la conquista del potere politico. Lo stato di pacificazione che la borghesia s’è assicurata nei paesi più forti della catena è la dimostrazione più chiara di come la risoluzione delle ondate antagoniste e cicli di lotte, anche violenti, sul terreno economico sia possibile dentro un quadro di compatibilità con le esigenze capitalistiche e gli interessi borghesi. E questo nonostante fatti concreti che dimostrano quale futuro l’imperialismo offra al proletariato internazionale: una nuova guerra mondiale. In questo quadro la lotta autenticamente orientata far generare il comunismo non è lo strumento propagandistico per poi poterla fare, non è l’ultima forma di lotta propria della fase conclusiva dello scontro, ma la strategia che guida dall’inizio alla fine lo scontro necessariamente prolungato con l’apparato statale borghese. Tale tipologia di lotta si colloca all’interno dell’esperienza del proletariato internazionale e soprattutto del marxismo rivoluzionario che, coll’evolvere delle forme di dominio dello Stato e dell’imperialismo ha trovato e trova all’interno dello scontro di classe le ipotesi rivoluzionarie più adeguate per il raggiungimento dei propri obiettivi. Fermenti vivi per un'epoca nuova.
[Per consultazione: http://www.criticamente.com/marxismo/capitale/capitale_1/Marx_Karl_-_Il_Capitale_-_Libro_I_-_24.htm]
domenica 8 gennaio 2012
sabato 31 dicembre 2011
"Eternità", via di fuga dalla giustizia terrena ...
Don Luigi Maria Verze, fondatore del San Raffaele, è deceduto questa mattina, 31 dicembre, alle ore 7,30 circa presso l'Unita Coronarica dell'Ospedale.  Don Luigi era stato ricoverato durante la notte alle ore 2.30 per l'aggravarsi della sua situazione cardiaca. Lo precisa una nota del S.Raffaele. Dal San Raffaele fanno sapere che don Verzè, 91 anni, era tenuto sempre sotto stretto controllo dopo l'operazione al cuore subita l'anno scorso, ma probabilmente anche a causa della tensione dell'ultimo periodo causata dalle indagini per bancarotta le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Verzé era finito in bancarotta con debiti da un miliardo e mezzo di euro.proprio oggi si dovevano aprire le buste dell'asta per l'acquisto della struttura ospedaliera fondata nel 1958. La scomparsa di Don Luigi Verzè cade come un macigno sull'inchiesta in corso alla procura di Milano per il crac da 1,5 miliardi dell'ospedale San Raffaele e segue di qualche mese il suicidio del secondo grande protagonista della vicenda, il vicepresidente con le deleghe operative Mario Cal. Il procedimento giudiziario però, che conta una decina di indagati, non dovrebbe subire rallentamenti. Queste le tappe dell'inchiesta.
Don Luigi era stato ricoverato durante la notte alle ore 2.30 per l'aggravarsi della sua situazione cardiaca. Lo precisa una nota del S.Raffaele. Dal San Raffaele fanno sapere che don Verzè, 91 anni, era tenuto sempre sotto stretto controllo dopo l'operazione al cuore subita l'anno scorso, ma probabilmente anche a causa della tensione dell'ultimo periodo causata dalle indagini per bancarotta le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Verzé era finito in bancarotta con debiti da un miliardo e mezzo di euro.proprio oggi si dovevano aprire le buste dell'asta per l'acquisto della struttura ospedaliera fondata nel 1958. La scomparsa di Don Luigi Verzè cade come un macigno sull'inchiesta in corso alla procura di Milano per il crac da 1,5 miliardi dell'ospedale San Raffaele e segue di qualche mese il suicidio del secondo grande protagonista della vicenda, il vicepresidente con le deleghe operative Mario Cal. Il procedimento giudiziario però, che conta una decina di indagati, non dovrebbe subire rallentamenti. Queste le tappe dell'inchiesta.
Giovane violinista talentuosa di r_montalcini - 30 giugno: la Procura di Milano accende un 'farò sulla crisi del San Raffaele. Non ancora una vera e propria indagine ma il Pm Luigi Orsi avvia un 'protocollo civile' sulla ristrutturazione del debito dell'ospedale.
- 18 luglio: Si suicida Mario Cal, storico braccio destro di don Verzè nella gestione del San Raffaele, qualche giorno prima era stato sentito come teste dal pm Orsi.
- 19 luglio: Al vaglio della procura l'ipotesi di avanzare un'istanza di fallimento.
- 21 luglio: Il nuovo Cda del San Raffaele, appena insediatosi, chiede alla procura tre mesi per presentare un concordato preventivo. Il Pm da come 'ultimatum' la scadenza del 15 settembre.
- 22 luglio: Il fascicolo d'inchiesta sul suicidio di Cal passa ai Pm Luigi Orsi e Laura Pedio. Gli stessi che hanno acceso 'il farò sulla crisi finanziaria dell'ospedale.
- 20 settembre: La procura di Milano «prende atto» delle richieste dei rappresentantri del Cda che hanno promesso di presentare la richiesta di concordato preventivo il 10 ottobre.
- 29 settembre: Il Pm avanza la richiesta di fallimento per «arrestare ulteriori dissipazioni patrimoniali» e «perseguire - scrive il procuratore Edmondo Bruti Liberati - l'interesse pubblico nella sfera del quale rientra la posizione dei soggetti a vario titolo coinvolti in questo grave default, quali i creditori, i dipendenti, i collaboratori e gli stessi utenti del servizio sanitario gestito dalla fondazione». I Pm scrivono anche che dalle carte di Cal sono emersi «fatti di reato» e che vi sono degli indagati fra i quali, l'unico in quel momento certo, il direttore finanziario Mario Valsecchi per il quale si ipotizza il falso in bilancio e false scritture.
- 30 settembre: È ufficiale: i Pm Orsi e Pedio hanno avviato l'indagine per bancarotta, ostacolo agli organi di vigilanza e fatture false.
- 12 ottobre: Inizia l'udienza davanti al giudice fallimentare
- 28 ottobre: Il Tribunale fallimentare dichiara «ammissibile» il concordato preventivo presentato dai legali. I creditori vengono convocati per il 23 gennaio 2012.
- 16 novembre: parallelamente alla causa civile va avanti l'inchiesta penale e i Pm dispongono una ventina di perquisizioni; una decina gli indagati fra i quali Don Verzè, Valsecchi, Gianluca Zammarchi e Andrea Bezzicheri, esponenti della società 'Metodo srl'. Arrestato per concorso in bancarotta il 'faccendierè Piero Daccò.
- 17 novembre: Daccò è accusato di aver 'distrattò dalla Fondazione circa 3,3 milioni di euro.
- 18 novembre: nuovi particolari sull'inchiesta: Stefania Galli, segretaria di Cal parla di buste con denaro che passavano dall'ufficio del vicepresidente dal 2005.
- 19 novembre: Il Gip Vincenzo Tuchinelli convalida il fermo di Daccò.
- 13 dicembre: Viene arrestato l'ex direttore amministrativo Valsecchi. A lui e ad altre 9 persone viene contestata anche l'associazione a delinquere. Decisive sarebbero state le dichiarazioni di tre imprenditori, uno dei queli, Pierino Zammarchi, parla di sovraffatturazione di costi a carico dell'ospedale e retrocessione dei soldi al San Raffaele tramite buste di contanti e bonifici per 4 milioni. Fondi neri che sarebbero stati costituiti a partire dal 1983.
- 16 dicembre: Daccò interrogato dal Gip respinge le accuse.
- 31 dicembre: muore don Verzè. Nel Duemila, quando il cattolicesimo trionfava sull’orbe mediatico, negli uffici del Pontificio consiglio per la pastorale della salute tutti erano tristi. L’allora presidente, il messicano Lozano Barragán (diventato cardinale nel 2003), non faceva fatica a spiegare che nei laboratori scientifici del mondo la dottrina cattolica nel campo della bioetica era del tutto irrilevante. Anzi, il sospetto che facesse da corollario a quanto il buon presule aveva constatato nei numerosi viaggi presso le più grandi agenzie scientifiche, induceva a credere che non solo la teoria, ma ai ricercatori cattolici fosse precluso persino l’accesso nei laboratori dove la vita si scrutava e si manipolava. Per comprendere Don Verzè, forse bisogna partire da qui: egli è riuscito a creare un laboratorio diventato un punto di incontro fra ricercatori laici (comunque aperti ai riferimenti etici), e cattolici adulti, capaci cioè di porre seri interrogativi alla Chiesa e alla sua dottrina. Ma il San Raffaele non è solo un centro di ricerche biomediche e di risultati importanti. Dal 1972 è stato riconosciuto come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, divenendo quindi polo universitario a tutti gli effetti. Ed è l’unico luogo in Italia dove scienziati come Edoardo Boncinelli, Giulio Cossu, Luca Cavalli-Sforza, Roberta de Monticelli, Massimo Cacciari insegnano con colleghi cattolici senza temere le solite cacce alle streghe ciclicamente scatenate in altre istituzioni accademiche italiane, sia confessionali sia laiche .Eppure anche per i suoi non pochi nemici (specie nel mondo cattolico: memorabile, e di fuoco, la sua “querelle” contro la cattolica Rosy Bindi, allora ministro della Sanità, rea confessa di aver sbarrato l’espansione dell’opera di Don Verzè a Roma), il fondatore del San Raffaele di Milano ha sempre avuto grandi meriti. Il primo, quello di aver assunto “l’eccellenza” come ideale e dogma del suo agire: «Non voglio curare la gente nei lazzaretti», ha sempre affermato. Di conseguenza, è stato coraggioso ed illuminato nella scelta di collaboratori e medici, nell’aggiornamento dei macchinari e nelle opzioni di ricerca. Nel 2009, Maurizio Crippa e Nicoletta Tiliacos hanno pubblicato un’ampia inchiesta (3 puntate) sulla vita e le opere del prete-imprenditore veronese. Una delle loro annotazioni più interessanti, quella relativa alla «ricaduta» del modello sanraffaeliano sul sistema sanitario italiano. Contrariamente agli «imprenditori cattolici» che a Roma si sono arricchiti con le cliniche dismesse dalle suore e ricomprate (grazie ai “buoni uffici” delle solite tonache venali) per quattro soldi, Don Verzè è stato assai caparbio nell’evitare la trappola dell’equazione «cattolico» uguale «privato», cioè costoso e per pochi. Aprendo così una strada che «oggi è un dato acquisito in molte regioni italiane, a partire dalla formigoniana Lombardia che l’ha a sua volta desunta dal pensiero sociale dei discepoli di don Giussani, a loro volta debitori, sul fronte sanitario, di più di un’idea di don Verzé». Forse proprio per salvare la libertà di ricerca e di cura che il Vaticano (che ha un bilancio annuale inferiore agli incassi di Oprah Winfrey) sta scendendo in campo assumendosi un peso finanziario certamente superiore alle sue forze.
Nel Duemila, quando il cattolicesimo trionfava sull’orbe mediatico, negli uffici del Pontificio consiglio per la pastorale della salute tutti erano tristi. L’allora presidente, il messicano Lozano Barragán (diventato cardinale nel 2003), non faceva fatica a spiegare che nei laboratori scientifici del mondo la dottrina cattolica nel campo della bioetica era del tutto irrilevante. Anzi, il sospetto che facesse da corollario a quanto il buon presule aveva constatato nei numerosi viaggi presso le più grandi agenzie scientifiche, induceva a credere che non solo la teoria, ma ai ricercatori cattolici fosse precluso persino l’accesso nei laboratori dove la vita si scrutava e si manipolava. Per comprendere Don Verzè, forse bisogna partire da qui: egli è riuscito a creare un laboratorio diventato un punto di incontro fra ricercatori laici (comunque aperti ai riferimenti etici), e cattolici adulti, capaci cioè di porre seri interrogativi alla Chiesa e alla sua dottrina. Ma il San Raffaele non è solo un centro di ricerche biomediche e di risultati importanti. Dal 1972 è stato riconosciuto come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, divenendo quindi polo universitario a tutti gli effetti. Ed è l’unico luogo in Italia dove scienziati come Edoardo Boncinelli, Giulio Cossu, Luca Cavalli-Sforza, Roberta de Monticelli, Massimo Cacciari insegnano con colleghi cattolici senza temere le solite cacce alle streghe ciclicamente scatenate in altre istituzioni accademiche italiane, sia confessionali sia laiche .Eppure anche per i suoi non pochi nemici (specie nel mondo cattolico: memorabile, e di fuoco, la sua “querelle” contro la cattolica Rosy Bindi, allora ministro della Sanità, rea confessa di aver sbarrato l’espansione dell’opera di Don Verzè a Roma), il fondatore del San Raffaele di Milano ha sempre avuto grandi meriti. Il primo, quello di aver assunto “l’eccellenza” come ideale e dogma del suo agire: «Non voglio curare la gente nei lazzaretti», ha sempre affermato. Di conseguenza, è stato coraggioso ed illuminato nella scelta di collaboratori e medici, nell’aggiornamento dei macchinari e nelle opzioni di ricerca. Nel 2009, Maurizio Crippa e Nicoletta Tiliacos hanno pubblicato un’ampia inchiesta (3 puntate) sulla vita e le opere del prete-imprenditore veronese. Una delle loro annotazioni più interessanti, quella relativa alla «ricaduta» del modello sanraffaeliano sul sistema sanitario italiano. Contrariamente agli «imprenditori cattolici» che a Roma si sono arricchiti con le cliniche dismesse dalle suore e ricomprate (grazie ai “buoni uffici” delle solite tonache venali) per quattro soldi, Don Verzè è stato assai caparbio nell’evitare la trappola dell’equazione «cattolico» uguale «privato», cioè costoso e per pochi. Aprendo così una strada che «oggi è un dato acquisito in molte regioni italiane, a partire dalla formigoniana Lombardia che l’ha a sua volta desunta dal pensiero sociale dei discepoli di don Giussani, a loro volta debitori, sul fronte sanitario, di più di un’idea di don Verzé». Forse proprio per salvare la libertà di ricerca e di cura che il Vaticano (che ha un bilancio annuale inferiore agli incassi di Oprah Winfrey) sta scendendo in campo assumendosi un peso finanziario certamente superiore alle sue forze.
 Don Luigi era stato ricoverato durante la notte alle ore 2.30 per l'aggravarsi della sua situazione cardiaca. Lo precisa una nota del S.Raffaele. Dal San Raffaele fanno sapere che don Verzè, 91 anni, era tenuto sempre sotto stretto controllo dopo l'operazione al cuore subita l'anno scorso, ma probabilmente anche a causa della tensione dell'ultimo periodo causata dalle indagini per bancarotta le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Verzé era finito in bancarotta con debiti da un miliardo e mezzo di euro.proprio oggi si dovevano aprire le buste dell'asta per l'acquisto della struttura ospedaliera fondata nel 1958. La scomparsa di Don Luigi Verzè cade come un macigno sull'inchiesta in corso alla procura di Milano per il crac da 1,5 miliardi dell'ospedale San Raffaele e segue di qualche mese il suicidio del secondo grande protagonista della vicenda, il vicepresidente con le deleghe operative Mario Cal. Il procedimento giudiziario però, che conta una decina di indagati, non dovrebbe subire rallentamenti. Queste le tappe dell'inchiesta.
Don Luigi era stato ricoverato durante la notte alle ore 2.30 per l'aggravarsi della sua situazione cardiaca. Lo precisa una nota del S.Raffaele. Dal San Raffaele fanno sapere che don Verzè, 91 anni, era tenuto sempre sotto stretto controllo dopo l'operazione al cuore subita l'anno scorso, ma probabilmente anche a causa della tensione dell'ultimo periodo causata dalle indagini per bancarotta le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni. Verzé era finito in bancarotta con debiti da un miliardo e mezzo di euro.proprio oggi si dovevano aprire le buste dell'asta per l'acquisto della struttura ospedaliera fondata nel 1958. La scomparsa di Don Luigi Verzè cade come un macigno sull'inchiesta in corso alla procura di Milano per il crac da 1,5 miliardi dell'ospedale San Raffaele e segue di qualche mese il suicidio del secondo grande protagonista della vicenda, il vicepresidente con le deleghe operative Mario Cal. Il procedimento giudiziario però, che conta una decina di indagati, non dovrebbe subire rallentamenti. Queste le tappe dell'inchiesta. Giovane violinista talentuosa di r_montalcini - 30 giugno: la Procura di Milano accende un 'farò sulla crisi del San Raffaele. Non ancora una vera e propria indagine ma il Pm Luigi Orsi avvia un 'protocollo civile' sulla ristrutturazione del debito dell'ospedale.
- 18 luglio: Si suicida Mario Cal, storico braccio destro di don Verzè nella gestione del San Raffaele, qualche giorno prima era stato sentito come teste dal pm Orsi.
- 19 luglio: Al vaglio della procura l'ipotesi di avanzare un'istanza di fallimento.
- 21 luglio: Il nuovo Cda del San Raffaele, appena insediatosi, chiede alla procura tre mesi per presentare un concordato preventivo. Il Pm da come 'ultimatum' la scadenza del 15 settembre.
- 22 luglio: Il fascicolo d'inchiesta sul suicidio di Cal passa ai Pm Luigi Orsi e Laura Pedio. Gli stessi che hanno acceso 'il farò sulla crisi finanziaria dell'ospedale.
- 20 settembre: La procura di Milano «prende atto» delle richieste dei rappresentantri del Cda che hanno promesso di presentare la richiesta di concordato preventivo il 10 ottobre.
- 29 settembre: Il Pm avanza la richiesta di fallimento per «arrestare ulteriori dissipazioni patrimoniali» e «perseguire - scrive il procuratore Edmondo Bruti Liberati - l'interesse pubblico nella sfera del quale rientra la posizione dei soggetti a vario titolo coinvolti in questo grave default, quali i creditori, i dipendenti, i collaboratori e gli stessi utenti del servizio sanitario gestito dalla fondazione». I Pm scrivono anche che dalle carte di Cal sono emersi «fatti di reato» e che vi sono degli indagati fra i quali, l'unico in quel momento certo, il direttore finanziario Mario Valsecchi per il quale si ipotizza il falso in bilancio e false scritture.
- 30 settembre: È ufficiale: i Pm Orsi e Pedio hanno avviato l'indagine per bancarotta, ostacolo agli organi di vigilanza e fatture false.
- 12 ottobre: Inizia l'udienza davanti al giudice fallimentare
- 28 ottobre: Il Tribunale fallimentare dichiara «ammissibile» il concordato preventivo presentato dai legali. I creditori vengono convocati per il 23 gennaio 2012.
- 16 novembre: parallelamente alla causa civile va avanti l'inchiesta penale e i Pm dispongono una ventina di perquisizioni; una decina gli indagati fra i quali Don Verzè, Valsecchi, Gianluca Zammarchi e Andrea Bezzicheri, esponenti della società 'Metodo srl'. Arrestato per concorso in bancarotta il 'faccendierè Piero Daccò.
- 17 novembre: Daccò è accusato di aver 'distrattò dalla Fondazione circa 3,3 milioni di euro.
- 18 novembre: nuovi particolari sull'inchiesta: Stefania Galli, segretaria di Cal parla di buste con denaro che passavano dall'ufficio del vicepresidente dal 2005.
- 19 novembre: Il Gip Vincenzo Tuchinelli convalida il fermo di Daccò.
- 13 dicembre: Viene arrestato l'ex direttore amministrativo Valsecchi. A lui e ad altre 9 persone viene contestata anche l'associazione a delinquere. Decisive sarebbero state le dichiarazioni di tre imprenditori, uno dei queli, Pierino Zammarchi, parla di sovraffatturazione di costi a carico dell'ospedale e retrocessione dei soldi al San Raffaele tramite buste di contanti e bonifici per 4 milioni. Fondi neri che sarebbero stati costituiti a partire dal 1983.
- 16 dicembre: Daccò interrogato dal Gip respinge le accuse.
- 31 dicembre: muore don Verzè.
 Nel Duemila, quando il cattolicesimo trionfava sull’orbe mediatico, negli uffici del Pontificio consiglio per la pastorale della salute tutti erano tristi. L’allora presidente, il messicano Lozano Barragán (diventato cardinale nel 2003), non faceva fatica a spiegare che nei laboratori scientifici del mondo la dottrina cattolica nel campo della bioetica era del tutto irrilevante. Anzi, il sospetto che facesse da corollario a quanto il buon presule aveva constatato nei numerosi viaggi presso le più grandi agenzie scientifiche, induceva a credere che non solo la teoria, ma ai ricercatori cattolici fosse precluso persino l’accesso nei laboratori dove la vita si scrutava e si manipolava. Per comprendere Don Verzè, forse bisogna partire da qui: egli è riuscito a creare un laboratorio diventato un punto di incontro fra ricercatori laici (comunque aperti ai riferimenti etici), e cattolici adulti, capaci cioè di porre seri interrogativi alla Chiesa e alla sua dottrina. Ma il San Raffaele non è solo un centro di ricerche biomediche e di risultati importanti. Dal 1972 è stato riconosciuto come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, divenendo quindi polo universitario a tutti gli effetti. Ed è l’unico luogo in Italia dove scienziati come Edoardo Boncinelli, Giulio Cossu, Luca Cavalli-Sforza, Roberta de Monticelli, Massimo Cacciari insegnano con colleghi cattolici senza temere le solite cacce alle streghe ciclicamente scatenate in altre istituzioni accademiche italiane, sia confessionali sia laiche .Eppure anche per i suoi non pochi nemici (specie nel mondo cattolico: memorabile, e di fuoco, la sua “querelle” contro la cattolica Rosy Bindi, allora ministro della Sanità, rea confessa di aver sbarrato l’espansione dell’opera di Don Verzè a Roma), il fondatore del San Raffaele di Milano ha sempre avuto grandi meriti. Il primo, quello di aver assunto “l’eccellenza” come ideale e dogma del suo agire: «Non voglio curare la gente nei lazzaretti», ha sempre affermato. Di conseguenza, è stato coraggioso ed illuminato nella scelta di collaboratori e medici, nell’aggiornamento dei macchinari e nelle opzioni di ricerca. Nel 2009, Maurizio Crippa e Nicoletta Tiliacos hanno pubblicato un’ampia inchiesta (3 puntate) sulla vita e le opere del prete-imprenditore veronese. Una delle loro annotazioni più interessanti, quella relativa alla «ricaduta» del modello sanraffaeliano sul sistema sanitario italiano. Contrariamente agli «imprenditori cattolici» che a Roma si sono arricchiti con le cliniche dismesse dalle suore e ricomprate (grazie ai “buoni uffici” delle solite tonache venali) per quattro soldi, Don Verzè è stato assai caparbio nell’evitare la trappola dell’equazione «cattolico» uguale «privato», cioè costoso e per pochi. Aprendo così una strada che «oggi è un dato acquisito in molte regioni italiane, a partire dalla formigoniana Lombardia che l’ha a sua volta desunta dal pensiero sociale dei discepoli di don Giussani, a loro volta debitori, sul fronte sanitario, di più di un’idea di don Verzé». Forse proprio per salvare la libertà di ricerca e di cura che il Vaticano (che ha un bilancio annuale inferiore agli incassi di Oprah Winfrey) sta scendendo in campo assumendosi un peso finanziario certamente superiore alle sue forze.
Nel Duemila, quando il cattolicesimo trionfava sull’orbe mediatico, negli uffici del Pontificio consiglio per la pastorale della salute tutti erano tristi. L’allora presidente, il messicano Lozano Barragán (diventato cardinale nel 2003), non faceva fatica a spiegare che nei laboratori scientifici del mondo la dottrina cattolica nel campo della bioetica era del tutto irrilevante. Anzi, il sospetto che facesse da corollario a quanto il buon presule aveva constatato nei numerosi viaggi presso le più grandi agenzie scientifiche, induceva a credere che non solo la teoria, ma ai ricercatori cattolici fosse precluso persino l’accesso nei laboratori dove la vita si scrutava e si manipolava. Per comprendere Don Verzè, forse bisogna partire da qui: egli è riuscito a creare un laboratorio diventato un punto di incontro fra ricercatori laici (comunque aperti ai riferimenti etici), e cattolici adulti, capaci cioè di porre seri interrogativi alla Chiesa e alla sua dottrina. Ma il San Raffaele non è solo un centro di ricerche biomediche e di risultati importanti. Dal 1972 è stato riconosciuto come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, divenendo quindi polo universitario a tutti gli effetti. Ed è l’unico luogo in Italia dove scienziati come Edoardo Boncinelli, Giulio Cossu, Luca Cavalli-Sforza, Roberta de Monticelli, Massimo Cacciari insegnano con colleghi cattolici senza temere le solite cacce alle streghe ciclicamente scatenate in altre istituzioni accademiche italiane, sia confessionali sia laiche .Eppure anche per i suoi non pochi nemici (specie nel mondo cattolico: memorabile, e di fuoco, la sua “querelle” contro la cattolica Rosy Bindi, allora ministro della Sanità, rea confessa di aver sbarrato l’espansione dell’opera di Don Verzè a Roma), il fondatore del San Raffaele di Milano ha sempre avuto grandi meriti. Il primo, quello di aver assunto “l’eccellenza” come ideale e dogma del suo agire: «Non voglio curare la gente nei lazzaretti», ha sempre affermato. Di conseguenza, è stato coraggioso ed illuminato nella scelta di collaboratori e medici, nell’aggiornamento dei macchinari e nelle opzioni di ricerca. Nel 2009, Maurizio Crippa e Nicoletta Tiliacos hanno pubblicato un’ampia inchiesta (3 puntate) sulla vita e le opere del prete-imprenditore veronese. Una delle loro annotazioni più interessanti, quella relativa alla «ricaduta» del modello sanraffaeliano sul sistema sanitario italiano. Contrariamente agli «imprenditori cattolici» che a Roma si sono arricchiti con le cliniche dismesse dalle suore e ricomprate (grazie ai “buoni uffici” delle solite tonache venali) per quattro soldi, Don Verzè è stato assai caparbio nell’evitare la trappola dell’equazione «cattolico» uguale «privato», cioè costoso e per pochi. Aprendo così una strada che «oggi è un dato acquisito in molte regioni italiane, a partire dalla formigoniana Lombardia che l’ha a sua volta desunta dal pensiero sociale dei discepoli di don Giussani, a loro volta debitori, sul fronte sanitario, di più di un’idea di don Verzé». Forse proprio per salvare la libertà di ricerca e di cura che il Vaticano (che ha un bilancio annuale inferiore agli incassi di Oprah Winfrey) sta scendendo in campo assumendosi un peso finanziario certamente superiore alle sue forze.
sabato 24 dicembre 2011
PER EVITARE LA CATASTROFE SOCIALE LA VIA MAESTRA E' IL SOCIALISMO

*(Bozza di manifesto del MPL) *Il capitalismo è come una trottola, può tenersi in equilibrio solo se gira vorticosamente attorno al proprio asse. Per ruotare ha bisogno di due fattori: una spinta che gli imprima movimento e una superficie perfettamente piana. Se viene a mancare anche solo uno di questi due
fattori essa smette di ruotare, si accascia al suolo e si arresta.
La trottola del capitalismo occidentale sta schiantando perché la sua forza
di spinta è venuta a mancare proprio mentre avrebbe dovuto accrescere a
causa della superficie diventata accidentata, essendo la spinta il profitto
e la superficie il mercato mondiale.
*Il gioco vale la candela?
La forza motrice che muove lo sviluppo capitalistico non è il bene comune
ma il profitto, il bene privato di chi detiene il capitale. Quando non può
accrescere il profitto il capitale arresta la sua corsa, smette di
investire, blocca la produzione, smantella impianti e dunque licenzia, crea
disoccupazione, getta nella miseria anzitutto chi non ha altre risorse se
non quella di vendere al miglior offerente la propria capacità lavorativa.
Queste recessioni cicliche, connaturate al capitalismo, vengono chiamate
“crisi”. Ogni fase di espansione è seguita da una inevitabile contrazione.
Alcune di queste crisi sono però più profonde, sono sistemiche, investono
la gran parte dei settori economici e possono sfociare in depressioni di
lungo periodo. Le conseguenze sociali e geopolitiche possono essere
devastanti: pauperismo di massa, inasprimento dei conflitti sociali, caduta
di governi e regimi, guerra aperta tra gli stati.
Con simili sconquassi vanno al tappeto i due dogmi che sorreggono
l’ideologia dominante: quello per cui il capitale, facendo i propri
interessi, realizza quelli di tutti, e quello per cui il “libero” mercato è
il luogo che meglio assicura e distribuisce il benessere. La società è
quindi costretta, quando il capitalismo mette in luce i suoi limiti
congeniti, a considerare il rapporto tra i costi e i benefici del sistema,
e ove decidesse che il gioco non vale la candela, a cercare una via
d’uscita e a sperimentare nuovi modelli sociali e di vita.
*Il boomerang
Di portata epocale fu la crisi che il capitalismo occidentale conobbe negli
anni ’70 del secolo scorso. La tenace resistenza proletaria all’interno,
l’avanzata delle lotte di liberazione dei popoli oppressi e l’esistenza del
“blocco socialista” non consentirono al capitalismo di ricorrere alle
vecchie terapie. La risposta alla crisi fu la globalizzazione.
All’interno: smantellamento delle protezioni sociali, privatizzazioni delle
aziende e dei servizi pubblici, frantumazione delle grandi roccaforti
industriali, precarizzazione del lavoro, agevolazione dei flussi migratori,
lento abbassamento dei salari e dei redditi, boom del credito per
sorreggere il consumismo di massa. All’esterno, in classico stile coloniale, rapina sistematica delle risorse dei paesi poveri (non solo di materie prime, appunto, ma pure di forza-lavoro, manuale e intellettuale) e, grazie al ruolo guida imperiale
degli Stati Uniti, aggressioni, guerre e pressioni di ogni tipo per
soggiogare interi paesi e spazzare via i regimi considerati ostili.
L’imperialismo, al prezzo di prosciugare le sue casse, ha vinto la “guerra
fredda” e rovesciato regimi nazionali considerati “canaglia”, ma ciò ha
prodotto nuovi esplosivi squilibri regionali e mondiali.
Il tutto nel quadro di una deregolamentazione sistematica dei mercati,
dell’abbattimento di ogni barriera ai movimenti di capitale, della
competizione selvaggia tra multinazionali e aziende, paesi e aree
economiche. Questa globalizzazione dei mercati, che le potenze occidentali
hanno tenacemente perseguito fino a spazzare via ogni ostacolo, si è
rivelato un boomerang. L’ampia superficie piana per far girare la trottola
si è trasformata in un terreno minato.
 *Il fallimento - *La globalizzazione ha infatti prodotto alcuni effetti macroscopici. Essa ha fatto emergere nuove potenze economiche, Cina *in primis*, che sfidano oramai apertamente quella supremazia che l'occidente - nel
*Il fallimento - *La globalizzazione ha infatti prodotto alcuni effetti macroscopici. Essa ha fatto emergere nuove potenze economiche, Cina *in primis*, che sfidano oramai apertamente quella supremazia che l'occidente - neldisperato tentativo di evitare un inesorabile declino - cerca di difendere
in ogni modo, anche a rischio di nuove gravissime tensioni geopolitiche.
Al contempo la globalizzazione ha sprofondato nella recessione una serie di
paesi poveri privi di materie prime, portando centinaia di milioni di
persone alla fame, di qui grandi rivolte sociali, come quelle che hanno
portato alla caduta di regimi totalitari nei paesi arabi.
Ma una delle conseguenze è che anche l’Occidente si è impoverito. I
capitali occidentali, privi di freni, sono fuggiti via per fare razzie nei
nuovi territori di caccia. In virtù dei bassi salari, dei regimi
neoschiavistici di sfruttamento e repressione, dei sistemi fiscali di
vantaggio dei paesi presi di mira, le imprese occidentali hanno accumulato
enormi guadagni.
Questi tornavano sì in Occidente ma per finire nella grande bisca del
capitalismo casinò, per essere gettati nel gioco d’azzardo di una
speculazione finanziaria fondata sul debito. Somme colossali venivano
offerte in prestito ai cittadini per sorreggere domanda interna e consumi
in calo a causa della caduta del potere d’acquisto dei salari, e agli stati
per puntellare i loro bilanci falcidiati da scellerate politiche
privatizzatrici. In questo tritacarne sono quindi finiti gli Stati e le
banche centrali. I primi accettando di gettare i debiti sovrani nei mercati
finanziari internazionali, le seconde o stampando a tutto spiano carta
moneta per sorreggere banche fallite o in procinto di fallire. Questo
sollazzo non poteva durare all’infinito: moneta, obbligazioni e titoli per
quanto simboli astratti sono pur sempre espressione di valori reali, sempre
tenendo conto che il lavoro e la natura sono le due sole fonti da cui
sgorga la ricchezza di una società.
*Mutamenti epocali
La finanziarizzazione liberista dell’economia ha agito come una droga. Per
sopravvivere il capitale aveva bisogno di dosi sempre più massicce di
liquidità, acquistando dalle banche centrali denaro a basso costo per poi
lucrare rivendendolo a tassi usurai. Ma nella bisca, il gioco è sempre a
somma zero: a fronte di chi vince, c’è sempre qualcun altro che perde. Chi
ci ha rimesso le penne è stato anzitutto il lavoro salariato, che in tre
decenni si è visto scippato di buona parte delle sue conquiste ed ha subito
una drastica riduzione della quota di reddito sociale a sua disposizione;
scippo compensato dall’elargizione di crediti che hanno trasformato buona
parte dei lavoratori in debitori permanentemente sotto ricatto.
La globalizzazione ha quindi indotto profonde trasformazioni nel corpo
stesso delle società occidentali, sia in alto che in basso.
In alto: la rendita, ovvero il capitale finanziario speculativo (denaro che
si accresce senza passare per il ciclo produttivo di merci) ha preso il
sopravvento su quello industriale; e in esso il vero *dominus *è diventato
il settore bancario predatorio (banche d’affari); in seno alla classe
capitalista sono diventati prevalenti i ceti parassitari che vivono di
rendita; gli stati nazionali sono stati privati della loro sovranità
politica; parlamenti e governi, espropriati delle loro prerogative, sono
diventati passacarte; i partiti si sono trasformati in meri comitati
d’affari, selettori dei funzionari al servizio dell’oligarchia.
In basso i mutamenti non sono stati meno profondi. Il dato fondamentale è
che al crollo del lavoro produttivo è corrisposta la crescita di quello
improduttivo o direttamente parassitario. Il processo di
deindustrializzazione e di smantellamento dei settori statali ha causato un
vero e proprio sfaldamento del tessuto sociale. Scomparsi o quasi i grandi
poli industriali, gran parte del lavoro è stato appaltato a piccole e medie
aziende, dove i salari sono più bassi ed è molto più difficile per i
lavoratori tutelare i propri interessi. Allo smembramento della vecchia
classe operaia industriale è corrisposta la crescita dei settori
impiegatizi, di mestieri del tutto nuovi, di lavori socialmente necessari
ma spesso improduttivi. Il posto fisso ormai è stato in gran parte
rimpiazzato dal lavoro precario e flessibile. Le conseguenze sono state
devastanti: un disgregazione sociale senza precedenti causa prima
dell’implosione dei tradizionali vincoli comunitari e dei tessuti
aggregativi, e il sopravvento di un’ideologia individualistica pervasiva,
refrattaria ad ogni istanza solidale e collettiva.
*La crisi italiana
Nella crisi globale dell’Occidente imperialistico c’è la specifica crisi
dell’Unione europea e dentro quest’ultima la crisi italiana. Essa si
presenta come un processo che vede coinvolti simultaneamente l’economia, le
istituzioni repubblicane, la società civile. All’evidente incapacità della
classe dominante di governare il paese (il cui sfascio è emblematico), fa
da contraltare la totale inadeguatezza delle classi subalterne a conformare
un’alternativa. L’ingresso nell’Unione europea e l’adozione dell’euro, che
le classi dominanti avevano pervicacemente perorato come la maniera per
porre fine alle strutturali distorsioni italiane, si sono rivelati invece
un fiasco totale. La sostanziale cessione di sovranità, monetaria, politica
e istituzionale —accettata fideisticamente dalla classe dirigente italiana
ma non da quelle tedesche e francesi, né tanto meno dai paesi che come il
Regno Unito hanno rifiutato di accettare l’euro— ha finito per aggravare
tutti gli squilibri, all’esterno come all'interno.
 In questo contesto, l’inevitabile crollo dell’Unione e dell’euro rischiano di essere un evento catastrofico, le cui conseguenze più pesanti verranno fatte pagare al popolo lavoratore, privato oramai di ogni autodifesa.
In questo contesto, l’inevitabile crollo dell’Unione e dell’euro rischiano di essere un evento catastrofico, le cui conseguenze più pesanti verranno fatte pagare al popolo lavoratore, privato oramai di ogni autodifesa.L’alternativa secca è tra il subire questa catastrofe sociale —che non è un
singolo evento fatidico, ma un processo già in atto— o sollevarsi per un
vero e proprio cambio di sistema. Se questo rivolgimento non ci sarà
presto, il paese sarà ridotto in macerie, col rischio che la miseria
generale possa causare un devastante conflitto tra poveri ed infine
lasciare spazio ad avventure populiste e reazionarie, animate da una
borghesia che tiene sempre in serbo primigenie pulsioni reazionarie, senza
nemmeno escludere l’eventualità di uno sgretolamento dello Stato-nazione.
Conflitti aspri saranno inevitabili, così come una polarizzazione di forze
contrapposte.
Di sicuro la crisi sprigionerà grandi energie sociali, energie che questo
sistema politico marcio sarà incapace di ammansire e rappresentare. Queste
forze sono la sola leva su cui si possa fare affidamento per cambiare
radicalmente questo paese. Vanno quindi alimentate, aiutate ad emergere.
Bisogna dare loro una consistenza politica, uno sbocco, una prospettiva.
Per farlo non è sufficiente affermare dei no, occorre anche indicare quale
possa essere l’alternativa, il nuovo modello sociale.
Questo è esattamente il compito che ci proponiamo come Movimento Popolare
di Liberazione (MPL). Esso non consiste anzitutto nell’accendere fuochi di
conflitto sociale, poiché essi già esistono come risultato di una
resistenza diffusa che scaturisce da condizioni oggettive. Il compito
nostro è quello di risvegliare le coscienze sopite, di chiamare a raccolta
le migliori intelligenze, di raggruppare e dunque di far scendere in campo
centinaia e migliaia di cittadini che di fronte alla miseria sociale e
politica generale, sono decisi a prendersi ognuno la propria
responsabilità, fino a quella di battersi per rovesciare lo stato di cose
esistenti.
*Fronte ampio e governo popolare**
Parallelamente alla fondazione di una nuova forza politica, il *MPL*, noi
ci battiamo per unire tutte le forze che avvertono la minaccia incombente e
che non solo si limitano ad opporre dei no, ma che vogliono sfidare le
classi dominanti avanzando soluzioni efficaci e realistiche per portare il
paese fuori dal marasma. Si tratta quindi di attivare un Fronte ampio che
sappia candidarsi alla guida del paese per dar vita a un governo popolare
di emergenza. Tanti sono i problemi, numerose le trasformazioni sociali
necessarie, ma esse fanno capo a poche misure sostanziali.
*- Abbandonare l’euro per riprenderci la sovranità monetaria.
*L’euro ci fu presentato come una panacea per curare i mali strutturali
dell’economia italiana (tra cui l’alto debito pubblico e una competitività
fondata solo sui bassi salari) e risolvere gli squilibri tra gli Stati
comunitari. A dieci anni di distanza non solo il debito pubblico è
aumentato, ma l’economia è in stagnazione e la competitività è diminuita.
Le politiche antipopolari di austerità perseguite da tutti i governi,
presentate come necessarie per restare nell’Unione e difendere l’euro si
sono dimostrate del tutto inutili, se non nel fare dell’Italia un paese più
povero. L’euro e i principi di Maastricht hanno accresciuto gli squilibri
in seno all’Unione europea, determinando uno spostamento di risorse
dall’Italia verso i paesi più “virtuosi”, la Germania anzitutto, che non
hai mai messo i suoi propri interessi nazionali dietro a quelli comunitari.
La ricchezza di un paese non dipende certo dalla moneta, ma dal lavoro che
la crea, e poi da come essa viene distribuita. La moneta è tuttavia una
leva per agire sul ciclo economico, un mezzo per decidere come viene
distribuita la ricchezza sociale. Un paese che non disponga della sovranità
monetaria, tanto più se alle prese con la speculazione finanziaria
globalizzata, è come una città assediata priva di mura di cinta. Occorre
ritornare alla lira, ponendo la Banca d’Italia sotto stretto controllo
pubblico, affinché l’emissione di moneta sia funzionale all’economia e al
benessere collettivo e non alle speculazioni dei biscazzieri dell’alta
finanza.
 *-Nazionalizzare il sistema bancario e i gruppi industriali strategici.
*-Nazionalizzare il sistema bancario e i gruppi industriali strategici.*Agli inizi degli anni ’80 venne permesso alle banche italiane, in ossequio
ai dettami neoliberisti, di diventare banche d’affari, di utilizzare i
risparmi dei cittadini per investirli e scommetterli nella bisca del
capitalismo-casinò. Prese avvio una politica di privatizzazione delle
banche e di concentrazione, che ha coinvolto anche gli enti assicurativi,
gettatisi voraci sul malloppo dei fondi pensione. Banche e assicurazioni
sono oggi le casseforti che custodiscono gran parte della ricchezza
nazionale. Esse debbono essere nazionalizzate, affinché questa ricchezza,
invece di partecipare al gioco d’azzardo finanziario, sia utilizzata per il
bene del paese. Debbono poi ritornare in mano pubblica le aziende di
rilevanza strategica, sottraendole agli artigli dei mercati finanziari e
borsistici come dalla logica perversa del profitto d’impresa.
Contestualmente andrà rafforzata la gestione pubblica dei beni comuni come
l’ambiente, l’acqua, l’energia, l’istruzione, la salute.
*- Per una moratoria sul debito pubblico e la cancellazione di quello estero
*Il debito pubblico accumulato dallo Stato è usato da un decennio come
la *Spada di Damocle* per tagliare le spese sociali, giustificare le misure
d’austerità ed una tra le più alte imposizioni fiscali del mondo. Esso è
diventato fattore distruttivo da quando, agli inizi degli anni ’90, i
governi hanno immesso i titoli di debito nella giostra delle borse e dei
mercati finanziari internazionali. Da allora i creditori divennero i fondi
speculativi, le grandi banche d’affari estere e italiane. Il debito
pubblico, gravato di interessi crescenti, non è niente altro che un
drenaggio di risorse dall’Italia verso la finanza speculativa, banche
italiane comprese.
Per questo riteniamo ingiusto, antipopolare e suicida per il futuro del
paese fare del pagamento del debito un dogma. La rinascita dell’Italia
richiede la protezione dell’economia nazionale dal saccheggio dei predoni
della finanza imperialista. Ciò implica impedire ogni fuga di capitali
verso l’estero, incluso il pagamento del debito estero perché esso non è
altro che una forma di espatrio legalizzato, di rapina autoinflitta. Non
rimborsare gli strozzini della finanza globale non è una opzione, ma una
necessità.
Non solo è ingiusto, ma in base al rapporto costi/benefici è economicamente
irrazionale tentare di rispettare la clausola del Trattato di Maastricht
che impone un rapporto debito/Pil non superiore al 60%. Ciò implica
ripetere per ben 25 anni, e non è detto che sia sufficiente a causa della
depressione economica, manovre d’austerità da 30 miliardi all’anno.
Sbaglia dunque chi si fa spaventare dagli strozzini che evocano lo
spauracchio del “default”. Il male minore per l’Italia è un default
programmato e pianificato, una moratoria e dunque una rinegoziazione del
debito, che i creditori dovranno accettare, pena il ripudio vero e proprio.
Per quanto riguarda il debito con le banche e le assicurazioni italiane,
dal momento che saranno nazionalizzate, esso sarà *de facto* cancellato. Il
solo debito pubblico che lo Stato rimborserà, a tassi e scadenze
compatibili con le esigenze della rinascita economica e sociale del paese,
sarà quello posseduto dalle famiglie italiane.
*- Debellare la disoccupazione con un piano nazionale per il lavoro
*La natura e il lavoro sono le sole fonti da cui sgorgano il benessere e la
ricchezza sociale. Proteggere l’ambiente e assicurare a tutti i cittadini
un lavoro sono le due priorità di un governo popolare. Ciò implica che
esso, liberatosi dal feticcio della cosiddetta “crescita economica”
misurata in Pil, dovrà sottomettere l’economia, pubblica e privata, alla
politica, ovvero ad una visione coerente della società, in cui al centro ci
siano l’uomo e la sua qualità della vita. Non si vive per lavorare ma si
deve lavorare per vivere. Si produrrà il giusto per consumare il
necessario. Solo così si potrà uscire dalla trappola produzione-consumo per
affermare un nuovo paradigma produzione-benessere.
*- Uscire dalla NATO e dall’Unione europea, scegliere la neutralità.
*Attraverso la NATO l’Italia è incatenata ad un patto strategico che oltre
a farla vassalla dell’Impero americano, la obbliga a seguire una politica
estera aggressiva, neocolonialista e guerrafondaia. Uscire dalla NATO e
chiudere le basi e i centri strategici militari americani in Italia è
necessario per riacquisire la piena sovranità nazionale, scegliere una
posizione di neutralità attiva e una politica di pace. L’uscita dall’Unione
europea, inevitabile se si ripudiano, come occorre fare, i Trattati di
Maastricht e di Lisbona, non vuol dire chiudere l’Italia in un guscio
autarchico, al contrario, vuol dire puntare a diversi orizzonti
geopolitici, aprendosi alla cooperazione più stretta con l’area
Mediterranea, stringendo rapporti di collaborazione con l’America latina,
l’Africa e l’Asia.
*- Rafforzare la Costituzione repubblicana per un’effettiva sovranità
popolare
*La cosiddetta “Seconda repubblica” si è fatta avanti calpestando i dettami
della carta costituzionale. L’abolizione delle legge elettorale
proporzionale, il bipolarismo coatto, i poteri crescenti dell’Esecutivo, la
trasformazione del Parlamento in un parlatoio per replicanti spesso
corrotti, erano misure necessarie per assecondare i torbidi affari di
banchieri e pescecani del grande capitale, nonché per sottomettere il paese
e la politica ai *diktat* e agli interessi della finanza globale. La
Costituzione va difesa contro i suoi rottamatori, se necessario dando vita
ad una Assemblea costituente incaricata di rafforzarne i dispositivi
democratici a tutela della piena ed effettiva sovranità popolare.
*Sovranità nazionale e socialismo
 Non vediamo oggi, in seno alle classi dominanti italiane componenti
Non vediamo oggi, in seno alle classi dominanti italiane componentidisposte a battersi sul serio per uscire dall’Unione europea, sganciare
l’Italia dalla morsa della globalizzazione liberista per ricollocarla
dentro nuovi scenari geopolitici. Ove domani si manifestassero il popolo
lavoratore non dovrebbe esitare a costituire un’alleanza comune.
Compito pressante dell’oggi è costruire un fronte ampio del popolo
lavoratore, un'alleanza solida tra il proletariato e parti consistenti
delle classi medie. Dentro questa alleanza il proletariato non dovrà stare
a rimorchio ma agire da forza motrice. E per questo serve un soggetto
politico rivoluzionario, che aiuti la classe degli sfruttati a diventare
classe dirigente nazionale. Solo un fronte popolare con al centro i
lavoratori può avere la forza e la determinazione per un cambio di sistema
capace di portare l’Italia fuori dal marasma. E' da questo contesto che
discendono i compiti, le funzioni e il profilo del Movimento Popolare di
Liberazione.
Ma essi dipendono anche dalla nostre finalità, dai nostri scopi ultimi.
Vi è ancora chi considera l’uscita dall’Unione europea e l’abbandono
dell’euro come idee velleitarie ed estremistiche. E’ vero esattamente il
contrario. Il disfacimento dell’Unione europea e la fine dell’euro sono
processi oggettivi, oramai irreversibili. Velleitari sono coloro che si
illudono di fermare queste tendenze facendo gli esorcismi, mettendo toppe
che sono peggiori del buco. Estremisti psicotici sono gli oligarchi di
Francoforte e Bruxelles, disposti a dissanguare intere nazioni pur di
tenere in vita una moneta moribonda e ingrassare la rendita parassitaria.
Il problema non è se abbandonare l’euro o meno, il problema è chi guiderà
questo processo. Se al potere resteranno i servi politici del capitalismo
finanziario ne faranno pagare le salate conseguenze alle masse lavoratrici.
Se sarà un governo popolare a pilotare l’uscita, i sacrifici, certo
inevitabili, saranno anzitutto addossati ai parassiti, e i frutti di questi
sacrifici saranno utilizzati per il bene comune della maggioranza e la
rinascita del paese.
E’ in questo quadro che il MPL considera la riconquista della sovranità
nazionale una stella polare. Senza sovranità nazionale non c’è quella
popolare, non c’è democrazia. Solo riconquistando questa sovranità
politica, economica e monetaria il paese può risorgere su nuove basi,
sgangiandosi dalla soffocante morsa dei mercati finanziari internazionali
per proiettarsi verso altri orizzonti regionali e mondiali. Se Un’Europa
dei popoli vedrà un giorno luce essa nascerà sulle macerie di quella di
Maastricht.
Siccome è sotto gli occhi di tutti che non siamo alle prese con una
recessione ciclica ma con una crisi storico-sistemica di un modello di
produzione e di vita, dovere di chi guarda al futuro è immaginare
un’alternativa di società e agire per realizzarla. Sarebbe assurdo fare
grandi sacrifici per poi ritrovarci alle prese con una società esposta a
crisi cicliche devastanti, incapace di assicurare un reale benessere
collettivo, generatrice di diseguaglianze e squilibri, lacerata dai
conflitti sociali.
Il *MPL* scende in campo per contrastare questa crisi e soprattutto per
uscire dal sistema neoliberista globalizzato che ha fatto del capitalismo
un dogma. Per liberare il paese dalla corruzione, dalle ingiustizie, dalla
dittatura delle banche e della finanza internazionale. Per liberarci dalla
dittatura del mercato. Scende in campo per non accettare supinamente la
distruzione sistematica della natura, della nostra vita e del futuro delle
nuove generazioni; per affermare che l'alternativa è una società socialista
che metta l'economia al servizio della collettività e della difesa di tutti
i beni comuni.
 Sappiamo che questo approdo è ancora lontano, che occorrono tempi lunghi affinché lavoratori e cittadini possano riuscire a prendere in mano i loro destini. Solo allora la società sarà matura per fare a meno del mercato, per togliere ai mezzi di produzione e di scambio la loro forma capitalistica e ai beni la loro forma di merce.
Sappiamo che questo approdo è ancora lontano, che occorrono tempi lunghi affinché lavoratori e cittadini possano riuscire a prendere in mano i loro destini. Solo allora la società sarà matura per fare a meno del mercato, per togliere ai mezzi di produzione e di scambio la loro forma capitalistica e ai beni la loro forma di merce.Fino ad allora coesisteranno forme diverse di proprietà, quelle
capitalistiche e quelle statali, quelle pubbliche e quelle autogestite.
Fermo restando che il governo popolare dovrà aiutare il nuovo a crescere e
il vecchio a perire.
L’alternativa di oggi è lottare o soccombere. Quella di domani sarà la
liberazione o il ritorno a forme più brutali di oppressione.
martedì 29 novembre 2011
MURALE di MILWAUKEE HARING a Chieti - Museo archeologico nazionale
«... le immagini create dall'uomo sono sempre state elementi importanti e necessari di questo rituale che noi chiamiamo vita ... L'immaginazione non può essere programmata da un computer. L'immaginazione è la nostra più grande speranza di sopravvivenza». Keith Haring, Diari, 31 maggio 1983 - Uno dei maggiori esponenti della corrente neo-pop, è stato tra gli artisti più rappresentativi della sua generazione. Figlio di Joan e Allen Haring e maggiore di quattro fratelli, nasce il 4 maggio 1958 a Kutztown, in Pennsylvania. Rivela il suo talento artistico già molto giovane e, dopo aver regolarmente frequentato le scuole superiori, entra alla Ivy School of Professional Art di Pittsburgh. Nel 1976, sull'onda della nuova contestazione giovanile e della cultura hippie, gira gli Stati Uniti in autostop, facendo tappa nelle varie città del paese allo scopo di osservare più da vicino i lavori degli artisti della scena americana. Tornato a Pittsburgh lo stesso anno, entra all'Università e tiene la sua prima importante esposizione al Pittsburgh Arts and Crafts Center. Figlio della cultura di strada, parto felice della cosiddetta street art newyorkese, prima della sua consacrazione all'interno del mondo "ufficiale" dell'arte è stato inizialmente un emarginato. Nel 1978 entra alla School of Visual Arts di New York, diventando noto nei primi anni '80 con i murales realizzati nelle metropolitane e, più tardi, con i lavori esposti qua e là, fra Club di vario genere e "vernissage" più o meno improvvisati. Le novità proposte dall'artista americano sono esplosive e non mancano di attirare l'attenzione degli intenditori più smaliziati. Keith Haring trasmette e inventa un nuovo linguaggio urbano, costituito da sagome quasi infantili o primitive, caratterizzate da un continuo segno nero che si rifà palesemente al fumetto. La sua prima vera mostra personale si tiene a Shafrazi nel 1982; gli anni successivi sono densi di successi con mostre in tutto il mondo. Nell'aprile del 1986 Keith Haring apre il Pop Shop, a New York. Ormai è un artista affermato, acclamato in tutto il mondo. Nel 1988 gli viene diagnosticato l'Aids. Con un colpo a sorpresa annuncia lui stesso la sua triste condizione in un'intervista a "Rolling Stone", incrementando così la sua già grande popolarità. Prima della sua morte fonda la Keith Haring Foundation, che si propone tutt'oggi di continuare la sua opera di supporto alle organizzazioni a favore dei bambini e della lotta all'AIDS. Keith Haring è morto il 16 febbraio 1990, all'età di 32 anni.
Iscriviti a:
Post (Atom)